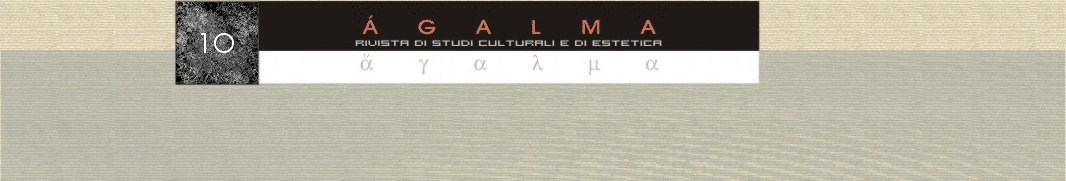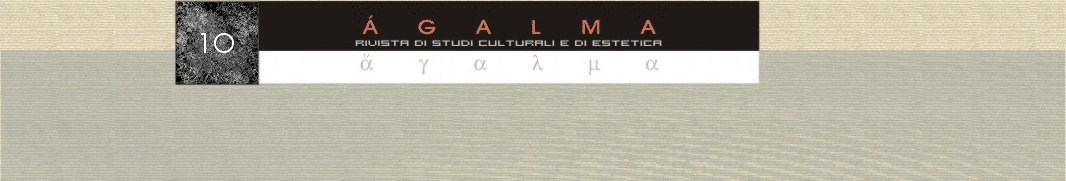Se, come dice Fernando Pessoa, la lingua portoghese é adatta
ad esprimere più una "metafisica delle sensazioni" che vere
e proprie nozioni filosofiche, è inutile sforzarsi di cogliere il nucleo
concettuale del tropicalismo brasiliano. Esso infatti si presenta - come mostrano
i saggi raccolti in questo numero di "Ágalma" - ora come
l'immagine del Brasile elaborata dagli europei, ora come un tema integrativo
e distintivo elaborato dagli stessi brasiliani per denotare i tratti essenziali
della loro cultura. Inoltre i contenuti di tale modello sono così vari
e perfino contraddittori che è pressoché impossibile ricondurli
ad un unica nozione. Questi tropici possono apparire allegri e addirittura
paradisiaci (secondo uno stereotipo che risale ai primi scopritori del Brasile
e che è stato fatto proprio dall'industria turistica), oppure tristi
e melanconici (come suggeriscono Paolo Prado, Lévi-Strauss e più
recentemente Moacyr Scliar), sublimi (secondo il modello antropofago che unisce
terrore e attrazione) oppure abietti (perché sprofondati nel piacere
e nell'inerzia), tradizionalisti (se ci si attiene al grande racconto storico-sociologico
elaborato da Gilberto Freyre) oppure futuristi (stando alla fondazione di
Brasilia che nasce da un avvenirismo utopistico), molto simili al mondo antico
(per la permanenza del paganesimo e della superstizione) oppure pervasi di
un'ansia escatologica (di cui la teologia della liberazione e le sette protestanti
sono la manifestazione), ipermoderni o postmoderni e chi più ne ha
più ne metta…
Insomma non esiste un solo tropicalismo, ma tanti tropicalismi quanti sono
i popoli e le culture che hanno contribuito a formare questo straordinario
paese, nel quale nonostante il perdurare di enormi ingiustizie socio-economiche,
l'estrema varietà fisica e culturale dei suoi abitanti e i 134 colori
della pelle censiti dall'Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica (IBGE),
tout se tient. Sicché al giorno d'oggi sembra che soltanto parole come
melting pot, ibridismo o meticciato siano adeguate a descrivere la cultura
brasiliana. Eppure proprio questa compresenza di permanente miserabilità
e di utopie tecnologico-religiose, di antropologia e di neofuturismo, che
costituisce un tratto specifico della società brasiliana, può
rivelarsi un modello estremamente pericoloso a partire dal momento in cui
si presenta non più come un'anomalia da correggere, ma come il nuovo
paradigma della società neo-liberale che ha abbandonato ogni serio
intento di miglioramento delle condizioni di vita della maggioranza e mira
alla radicalizzazione del dualismo tra la Lumpenmasse e la classe dirigente.
Questa dualizzazione appartiene alla logica della new-economy, la quale crea
una distanza sempre più grande tra i pochi che interiorizzano le finalità
della ditta e i molti che sono assunti temporaneamente per la realizzazione
di progetti specifici limitati nel tempo, i quali vedono degradata la loro
situazione economica, stabilità professionale e posizione sociale.
Ciò risulta evidentissimo se consideriamo l'urbanistica: quasi ovunque
(con l'eccezione del Giappone) le due forme urbane in crescita sono da un
lato shantytowns (favelas, barrios, bidonvilles), dall'altro gated communities
(i condomínios che - come scrive Luis Fernando Veríssimo - sono
costruiti con l'ossessione di garantire la segurança). Paradossalmente
quindi il Brasile passa da nazione arretrata in via di sviluppo a nazione-guida
del capitalismo neo-liberale, senza che nulla sia veramente cambiato! Il titolo
del famoso libro di Stefan Zweig, Brasilien, ein Land der Zukunft del 1941,
assume un significato minaccioso ed inquietante. Il neo-tropicalismo sarebbe
una forma particolarmente torva e truce di neo-ufanismo. La possibilità
di una modernità brasiliana alternativa rispetto alla modernità
americana sarebbe completamente scartata a favore di una ipermodernità
(o più-modernità, secondo l'espressione di Alfredo Bosi) di
stampo neo-liberistico. Del resto è proprio questa compresenza di degradazione
e di abiezione, da un lato, e di efficientismo tecnologico, dall'altro, che
tanti film di fantascienza ci hanno mostrato.
Tuttavia non si tratta di essere anti-moderni, ma di trovare altre dimensioni
di modernità in cui la dimensione pubblica sia valorizzata attraverso
il potenziamento e lo sviluppo di tendenze che appartengono profondamente
alla storia e alla cultura del paese, alle sue radici, per dirla con Sérgio
Buarque de Hollanda, l'autore del famoso volume Raízes do Brasil. Come
è noto, questo autore ha contrapposto la cordialità brasiliana
alla cortesia europea: la prima sarebbe caratterizzata da un'etica dell'affettività
e dell'emozione, che si manifesta nella ricerca di un rapporto intimo, nell'impiego
dei diminutivi, nell'omissione del nome di famiglia e in un generale stile
di vita caratterizzato da una benevolenza amichevole nei confronti del prossimo;
la seconda invece si fonda su relazioni impersonali che mirano a proteggere
la sfera intima dell'individuo. In realtà, come osserva lo stesso Buarque,
cordialità non vuol dire affatto bontà e, secondo l'interpretazione
psicoanalitica di Jorge Forbes, essa nasconderebbe l'incapacità dei
brasiliani di confrontarsi col desiderio, col perturbante, o in termini lacaniani,
col reale. Sottoposte perciò all'esercizio del sospetto, cordialità
e cortesia si rivelerebbero due differenti strategie rituali attraverso le
quali si è formata la civiltà moderna a partire dal Rinascimento:
la prima improntata alla vita di campagna e al modello dell'Arcadia, la seconda
alla vita di città e al modello curiale e cortigiano. In altre parole
la cordialità brasiliana non sarebbe affatto una manifestazione di
spontaneità e tantomeno un ritorno alla natura di tipo rousseauiano,
ma un rituale di origine manieristica ispirato a modelli arcadici. Il suo
prototipo sta nello "stile manuelino" di origine portoghese, caratterizzato
da una esuberante decorazione di motivi floreali e vegetali. È significativo
inoltre che il suo ingresso nell'età contemporanea non passi attraverso
il giacobinismo (come è avvenuto in altri paesi dell'America Latina),
ma attraverso il positivismo di Auguste Comte, da cui derivano appunto le
nozioni centrali di "ordine e progresso", riprodotte nel 1890 sulla
bandiera brasiliana: l'attitudine arcadica trova perciò un suo sviluppo
nell'altruismo, cioè nello sviluppo di una condotta ispirata dalla
socialità e dalla simpatia e non dall'individualismo o dalla deferenza.
Accanto alla cordialità e all'altruismo esiste però una terza
componente che appartiene non tanto alla storia del Brasile quanto alla sua
geografia, che non è tanto un concetto quanto un percetto (per usare
la terminologia di Gilles Deleuze e Félix Guattari) e che perciò
si presta meglio delle precedenti a conferire un senso più attendibile
al tropicalismo al di là delle interpretazioni ideologiche cui esso
ha dato luogo. Penso a quella esperienza di spaesamento e di sospensione suscitato
dal contatto con la natura tropicale che alcuni poeti e scrittori brasiliani
hanno colto molto bene e che costituisce il motivo di fondo del mio amore
per il Brasile. Per esempio dice Carlos Drummond de Andrade: "Somente
a contemplacão / de um mundo enorme e parado" (Solamente la contemplazione
/ di un mondo enorme e fermo). Oppure la scrittrice Clarice Lispector: "un
momento grande, fermo, senza nulla dentro". Questo sentire cosmico non
è un'alienazione, ma un'appropriazione: quindi non è lontana
dalla oikeiôsis di cui parlavano gli antichi filosofi stoici proprio
con riferimento al rapporto tra l'essere umano e la natura. In questa parola
greca (che è stata tradotta in latino con conciliatio e commendatio,
e in italiano con attrazione) è implicito sia l'aspetto affettivo della
cordialità, sia quello sociale dell'altruismo. Tale esperienza ha poco
che fare con la saudade portoghese, legata alla solitudine e al ricordo nostalgico
del passato. Perciò è la parola suavidade la più pertinente
al tropicalismo brasiliano. Soavità ha la stessa radice di persuasione:
non si tratta però di convincere o di comunicare un'idea. La soavità
è qualcosa di aconcettuale e di esprimibile solo attraverso la poesia,
la quale non a caso rappresenta uno dei migliori frutti della cultura brasiliana.
Mario Perniola