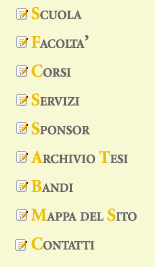Cultura e Territorio
Coordinatore
Prof. Franco Salvatori
Tel: +39 06/72595030
Email: salvatori@lettere.uniroma2.it
Collegio dei Docenti
Prof. Alessandro Carocci
Marco Fabbri
Prof. Daniel Fabre
Prof. Marina Faccioli
Daniela Felisini
Prof. Marcello Massenzio
Prof. Roberta Morelli
Sante Polica
Prof. Andreina Ricci
Prof. Franco Salvatori
Prof. Line Teisseyre-Salmann
International Partnerships
École des Hautes Études en Sciences Sociales,
Laboratoire d'anthropologie: l'institution de la cultur. (Ministère
de la culture/CNRS), France
Obiettivo formativo di base che la didattica
del dottorato si propone è fornire gli strumenti per la conoscenza
dei fattori e dei processi culturali che, in forme fortemente variabili
nel tempo, caratterizzano l'ambiente: tale obiettivo è, a sua
volta, finalizzato a definire e indicare le più idonee condizioni
di intervento per la difesa e la conservazione dell’ambiente stesso
mediante l'impiego di adeguati mezzi tecnologici.
Non rappresentando l’ambiente un concetto univoco, è opportuno
articolare l’impostazione didattica secondo diverse direttrici,
così da mettere a frutto la composizione interdisciplinare del
dottorato stesso.
Gli obiettivi principali che la didattica prevede sono:
• Acquisizione di metodologie di ricerca, anche su base cartografica,
per la definizione dell'ambiente in quanto contesto fisico.
Conoscenza dei fattori all'origine delle problematiche ambientali più
attuali, quali la distruzione delle foreste, l'erosione del suolo, la
desertificazione, l'assottigliarsi delle risorse e, complessivamente,
le modifiche dell'equilibrio ecologico.
Definizione di contesti relazionali fra queste problematiche e i processi
di crescita economica e di urbanizzazione.
Interpretazione delle componenti culturali e ideologiche che hanno prodotto
nel corso della storia recente il concetto di "etica ambientale".
Acquisizione delle dinamiche che governano azioni e retroazioni nell'ambito
degli assetti dell'ambiente naturale, guardando alla difesa dell'equilibrio
organizzativo di tipici ecosistemi: la via è da ricercare nell'analisi
territoriale che studia le trasformazioni delle relazioni naturali alla
luce dell'incidenza di fattori culturali.
• Conoscenza di metodologie di definizione dell'ambiente quale
contesto insediativo.
Uso di sistemi GIS (Geographical Information Systems) nell'ambito di
analisi predittive sui resti archeologici sommersi e per la gestione
di quelli emergenti.
Creazione di professionalità in grado di utilizzare tali tecnologie,
di estrema attualità e importanza in due ambiti differenti. Il
primo è quello della pianificazione delle trasformazioni del
territorio (urbano e rurale), sia di carattere edilizio che infrastrutturale.
Il secondo, di carattere più strettamente scientifico, vede nell'impiego
di tali tecnologie un supporto indispensabile per l'interpretazione
delle trasformazioni territoriali nel tempo.
Lo sviluppo ulteriore di tali sistemi informativi e le relative applicazioni,
opportunamente calibrate e mirate, all'analisi delle strutture insediative
di età medievale, moderna e contemporanea, si rivelano, per il
dottorato in questione, di importanza strategica, soprattutto in quanto
il carattere interdisciplinare di questo rende possibile il rapporto
fra le diverse competenze solo attraverso una rete di gestione delle
informazioni che possa essere disaggregata e riaggregata secondo metodologie
e finalità differenti.
• Acquisizione di strumenti per una lettura interpretativa del
concetto di ambiente di produzione, se necessario mediante l’impiego
di modelli e metodologie di elaborazione dei dati di impostazione sistemica.
L’ambiente produttivo si presenta contraddistinto da una elevata
pervasività delle tecnologie e da una sempre più vasta
pluralità di soggetti, in condizioni non più prevedibili
e a crescente variabilità. Insieme, questo stesso ambiente si
presenta sempre meno padroneggiabile mediante gli schemi teorici convenzionali
che attribuivano all'impresa, in particolare alla "grande impresa"
e ai processi di produzione standardizzata, il ruolo di centri di equilibrio
della dinamica storica del capitalismo industriale.
L'analisi territoriale, che costituisce nell'ambito del dottorato la
più significativa area di incontro in cui vanno a relazionarsi
i diversi obiettivi formativi, consente uno studio in termini di "flessibilità"
perché guarda all'ambiente produttivo come a un fattore di processi
non controllabili che, a loro volta, richiedono soluzioni di continuo
adattamento e modificazioni delle strategie operative. La stessa analisi
propone un approfondimento specifico dello studio dei sistemi territoriali
di produzione, con particolare riguardo alla scala locale, quali esempi
"canonici" della attuale complessità delle configurazioni
socio-territoriali.
Contemporaneamente, si vuole guardare a tanti ambienti e processi di
produzione quante sono le tipologie relazionali che si propongono nell'incontro
e nell'interazione, sempre più necessaria, fra diversi settori
socio-economici e fra le aree della produzione diretta e dei servizi:
questo avviene in condizioni di pluralismo delle tecnologie, globalizzazione
dei processi, interazione crescente fra imprese e mercati, accentuazione
della flessibilità organizzativa.
In sostanza, un obiettivo essenziale si intravede nel fornire un contributo
alla discussione sui numerosi aspetti del rapporto fra tecnologia, innovazione
tecnologica e ambienti di produzione e di mercato sempre più
diversificati e, tuttavia, interattivi. Un’ottica di indagine
con queste caratteristiche trova applicazione anche nel concetto, ampiamente
sperimentato nel territorio, di Parco Scientifico.
• Interpretazione del territorio quale ambiente culturale.
Un tema unificante dell’analisi impostata sul concetto, estremamente
composito e complesso, di “cultura ambientale” è
in larga parte riconducibile alla nuova accezione di “bene culturale”:
quest’ultimo viene inteso come risorsa tipica delle tradizioni
di un territorio, divenuta patrimonio essenziale per la definizione
e la conservazione di una specifica identità del territorio stesso
come ambiente originale.
Alla luce di queste tematiche è importante ricordare come il
dottorato riunisca per la prima volta in Italia intorno a un progetto
comune un insieme di input formativi che, per quanto legati da interessi
convergenti, non avevano mai avuto l’opportunità di interagire
nel concreto della ricerca e della didattica.
Proprio guardando l’ambiente come ad uno spazio da misurare con
strumenti tecnologici, analitici e/o operativi e allo stesso tempo come
“luogo” in cui si depositano le memorie culturali e si esprimono
i simboli dell’identità etnica, storica e sociale di gruppi
umani, è possibile individuare piani e processi di intervento
da parte di idonei apparati tecnologici.
• Interpretazione dell’ambiente/paesaggio come una realtà
ipertestuale
L’ipertesto risulta infatti uno strumento adeguato a rappresentare
il paesaggio, come insieme di segni visibili, più ancora di un
testo scritto in modo sequenziale, per alcune ragioni che hanno origine
nelle riflessioni sopra proposte sulla struttura sistemica dell’ambiente
in quanto contesto naturale e sociale. Si può giungere a proporre
un’analogia stretta tra l’uno e l’altro, a considerare
cioè il paesaggio stesso come un ipertesto. È stato sottolineato,
infatti, che la dimensione di relazione è fondamentale sia all’interno
del sistema ambiente/paesaggio, sia nelle sue relazioni con il sistema
realtà geografica; la struttura a nodi e link dei prodotti ipermediali
si presenta come una delle poche in grado di riprodurre tale insieme
di relazioni. Oltre ai contenuti esplicitati in ciascun nodo, infatti,
anche i link, per il modo stesso in cui sono stati costruiti, sono in
grado di trasmettere implicitamente dei contenuti.