IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6
febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 38 e l'articolo 3, lettera
f);
Vista la direttiva 92/32/CEE
del Consiglio del 30 aprile 1992, recante settima modifica della direttiva
67/548/CEE, del Consiglio del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento
delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative relative alla
classificazione, all'imballaggio e alla etichettatura delle sostanze
pericolose;
Vista la direttiva
91/410/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1991, recante quattordicesimo
adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE;
Vista la legge 29
maggio 1976, n. 256;
Vista la direttiva
93/67/CEE, della Commissione del 20 luglio 1993, che stabilisce i principi per
la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate
ai sensi della direttiva 67/548/CEE;
Vista la direttiva
93/90/CEE, della Commissione del 29 ottobre 1993, relativa all'elenco delle
sostanze di cui all'articolo 13, par. 1, quinto trattino, della direttiva
67/548/CEE;
Vista la direttiva
93/105/CE, della Commissione del 25 novembre 1993, che stabilisce l'allegato
VII D, contenente le informazioni necessarie alla redazione dei fascicoli
tecnici di cui all'articolo 12 della settima modifica della direttiva
67/548/CEE;
Vista la direttiva
96/56/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 1996, che
modifica la direttiva 67/548/CEE;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 1997;
Sulla proposta del
Presidente del consiglio dei ministri e del Ministro della sanità, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente;
Emana
il seguente decreto
legislativo:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
1
(Campo
di applicazione)
1. Il presente decreto
disciplina, relativamente alle sostanze di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
a) e c), anche se contenute in preparati allorchè tali sostanze siano immesse
sul mercato comunitario:
a) la notifica;
b) la valutazione dei
rischi che le sostanze notificate possono presentare per l'uomo e per
l'ambiente;
c) la classificazione,
l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose per l 'uomo e per
l'ambiente (1).
2. Le norme del
presente decreto non si applicano alle sostanze ed ai preparati seguenti che,
allo stato finito, sono destinati all'utilizzatore finale:
a) specialità
medicinali ad uso umano o ad uso veterinario;
b) prodotti cosmetici;
c) miscele di sostanze
in forma di rifiuti;
d) prodotti
alimentari;
e) alimenti per
animali;
f) antiparassitari;
g) sostanze
radioattive;
h) altre sostanze o
preparati per i quali esistono procedure comunitarie di notifica o di
approvazione sulla base di requisiti equivalenti a quelli stabiliti dal
presente decreto (2).
3. Il presente decreto
non si applica altresì:
a) al trasporto delle
sostanze e preparati pericolosi per ferrovia, su strada, per via fluviale,
marittima o aerea;
b) alle sostanze e
preparati in transito soggetti a controllo doganale quando non siano oggetto di
trattamento o trasformazione.
4. Le norme del
presente decreto si applicano, limitatamente alle operazioni di cui al comma 1,
lettera c), anche in caso di passaggio delle sostanze pericolose da una ad
altra unità produttiva della stessa impresa, ferma restando l'applicazione
delle ulteriori prescrizioni, per l'utilizzazione di dette sostanze e preparati
da parte dei lavoratori subordinati che il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, può
stabilire ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni.
----------
(1) Comma così
modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 febbraio 1998, n. 90.
(2) Lettera così modificata
dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 febbraio 1998, n. 90.
Art.
2
(Definizioni)
1. Ai fini del
presente decreto si intende per:
a) sostanze: gli
elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi
procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per mantenere la
stabilità dei prodotti e le impurezze derivanti dal procedimento impiegato, ma
esclusi i solventi che possono essere eliminati senza incidere sulla stabilità
delle sostanze e senza modificare la loro composizione;
b) preparati: le
miscele o le soluzioni costituite da due o più sostanze;
c) polimero: una
sostanza, composta di molecole caratterizzate dalla sequenza di uno o più tipi
di unità monomeriche, che comprenda una maggioranza ponderale semplice di
molecole contenenti almeno tre unità monomeriche aventi un legame covalente con
almeno un'altra unità monomerica o altro reagente e sia costituita da meno di
una maggioranza ponderale semplice di molecole dello stesso peso molecolare.
Tali molecole debbono essere distribuite su una gamma di pesi molecolari in cui
le differenze di peso molecolare siano principalmente attribuibili a differenze
nel numero di unità monomeriche. Nel contesto di tale definizione per
"unità monomerica" si intende la forma sottoposta a reazione di un
monomero in un polimero (1);
d) notifica: gli atti,
con le informazioni richieste, presentati, all'unità di notifica di cui
all'articolo 27 o all'autorità competente di altro Stato membro dell'Unione europea,
dal notificante quale definito alla lettera i);
e) immissione sul
mercato: la messa a disposizione di terzi e, in ogni caso, l'importazione nel
territorio doganale dell'Unione europea;
f) ricerca e sviluppo
scientifici: la sperimentazione scientifica o le analisi o le ricerche chimiche
effettuate in condizioni controllate, comprese la determinazione delle
proprietà intrinseche, degli effetti e dell'efficacia, nonchè le ricerche
scientifiche relative allo sviluppo del prodotto;
g) ricerca e sviluppo
di processo: ogni ulteriore sviluppo di una sostanza nel corso del quale i
settori di applicazione della sostanza stessa vengono controllati utilizzando
impianti pilota o prove di produzione;
h) EINECS (Inventario
Europeo delle Sostanze Commerciali Esistenti): l'inventario europeo delle
sostanze commerciali esistenti sul mercato comunitario alla data del 18
settembre 1981;
i) notificante: la
persona che presenta la notifica di cui al punto d), che può essere:
1) per le sostanze
fabbricate nell'Unione europea il fabbricante che immette sul mercato una
sostanza in quanto tale o incorporata in un preparato;
2) per le sostanze
fabbricate fuori dall'Unione europea, la persona stabilita nell'Unione europea
che sia responsabile dell'immissione sul mercato comunitario di una sostanza,
in quanto tale o incorporata in un preparato o la persona stabilita nella
comunità, che, allo scopo di presentare una notifica per una determinata
sostanza immessa sul mercato comunitario, in quanto tale o incorporata in un preparato,
è designata dal fabbricante come suo unico rappresentante.
2. Ai sensi del
presente decreto sono considerati pericolosi le sostanze ed i preparati:
a) esplosivi: le
sostanze ed i preparati solidi, liquidi, pastosi o gelatinosi che, anche senza
l'azione dell'ossigeno atmosferico, possono provocare una reazione esotermica
con rapida formazione di gas e che, in determinate condizioni di prova,
detonano, deflagrano rapidamente o esplodono in seguito a riscaldamento in
condizione di parziale contenimento;
b) comburenti: le
sostanze ed i preparati che a contatto con altre sostanze, soprattutto se
infiammabili, provocano una forte reazione esotermica;
c) estremamente
infiammabili: le sostanze ed i preparati liquidi con il punto di infiammabilità
estremamente basso ed un punto di ebollizione basso e le sostanze ed i
preparati gassosi che a temperatura e pressione ambiente si infiammano a
contatto con l'aria (2);
d) facilmente
infiammabili:
1) le sostanze ed i
preparati che, a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di
energia, possono subire innalzamenti termici e da ultimo infiammarsi;
2) le sostanze ed i
preparati solidi che possono facilmente infiammarsi dopo un breve contatto con
una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche
dopo il distacco della sorgente di accensione;
3) le sostanze ed i
preparati liquidi il cui punto d'infiammabilità è molto basso;
4) le sostanze ed i
preparati che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas estremamente
infiammabili in quantità pericolose;
e) infiammabili: le
sostanze ed i preparati liquidi con un basso punto di infiammabilità;
f) molto tossici: le
sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento
cutaneo, in piccolissime quantità, possono essere letali oppure provocare
lesioni acute o croniche;
g) tossici: le
sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento
cutaneo, in piccole quantità, possono essere letali oppure provocare lesioni
acute o croniche;
h) nocivi: le sostanze
ed i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo,
possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche;
i) corrosivi: le
sostanze ed i preparati che, a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare
su di essi un'azione distruttiva;
l) irritanti: le
sostanze ed i preparati con corrosivi, il cui contatto diretto, prolungato o
ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;
m) sensibilizzanti: le
sostanze ed i preparati che, per inalazione o assorbimento cutaneo, possono dar
luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva
esposizione alla sostanza o al preparato produce reazioni avverse
caratteristiche;
n) cancerogeni: le sostanze
ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono
provocare il cancro o aumentarne la frequenza;
o) mutageni: le
sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo,
possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;
p) tossici per il
ciclo riproduttivo: le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione
o assorbimento cutaneo, possono provocare o rendere più frequenti effetti
nocivi non ereditari nella prole o danni a carico della funzione o delle
capacità riproduttive maschili o femminili;
q) pericolosi per
l'ambiente: le sostanze ed i preparati che, qualora si diffondano
nell'ambiente, presentano o possono presentare rischi immediati differiti per
una o più delle componenti ambientali.
----------
(1) Lettera così
modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 febbraio 1998, n. 90.
(2) Lettera così
modificata dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 febbraio 1998, n. 90.
Capo II
SOSTANZE PERICOLOSE
Art.
3
(Determinazione
e valutazione delle proprietà
delle
sostanze)
1. Le prove relative
ai prodotti chimici da realizzarsi ai sensi del presente decreto sono
effettuate, di norma, conformemente ai metodi definiti nell'allegato V; in
particolare, la determinazione delle proprietà fisico-chimiche delle sostanze è
effettuata conformemente ai metodi previsti dall'allegato V, parte A; la
determinazione della loro tossicità è effettuata conformemente ai metodi di cui
all'allegato V, parte B, e quella della loro ecotossicità secondo i metodi
prescritti nell'allegato V, parte C.
2. Le prove di
laboratori di cui al comma 1 devono essere eseguite in conformità dei principi
in materia di protezione degli animali previsti dal decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 116, nonchè dei principi previsti dal decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 120, in materia di buone prassi di laboratorio.
3. Il rischio reale o
potenziale per l'uomo e per l'ambiente deve essere valutato sulla base dei principi
contenuti nel capo IV.
Art.
4
(Classificazione)
1. Le sostanze sono
classificate in base alle loro proprietà intrinseche, secondo le categorie di
cui all'articolo 2, comma 2; nella classificazione delle sostanze si tiene conto
delle impurezze qualora le loro concentrazioni superino i limiti di cui al
comma 3 o quelli previsti per i preparati pericolosi.
2. La classificazione
e l'etichettatura delle sostanze si effettuano secondo i criteri indicati
nell'allegato VI.
3. Per le sostanze
elencate nell'allegato I, devono essere utilizzate la classificazione e
l'etichettatura armonizzate ivi indicate; per determinate sostanze pericolose
sono riportati anche i limiti di concentrazione ed eventuali altri parametri
atti ad identificare il pericolo per la salute umana o per l'ambiente dei
preparati contenenti le suddette sostanze
o sostanze che contengano come impurezze altre sostanze pericolose (1).
4. L'inserimento di
altre sostanze nell'allegato I ed eventuali altre modifiche possono avvenire
soltanto a seguito di procedura comunitaria.
----------
(1) Comma così
modificato dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 1998, n. 90.
Art.
5
(Obblighi
generali)
1. Fatto salvo quanto
previsto all'articolo 13, le sostanze in quanto tali o contenute in preparati,
possono essere immesse sul mercato soltanto se sono state rispettate le
disposizioni relative alle schede informative in materia di sicurezza di cui
all'articolo 25 e se le sostanze stesse:
a) sono state
notificate all'unità di notifica ai sensi del presente decreto;
b) sono state
imballate ed etichettate conformemente agli articoli 19, 20, 21 e 22, nonchè ai
criteri di cui all'allegato VI ed ai risultati delle prove previste dagli
allegati VII e VIII, salvo se trattasi di preparati per i quali altre normative
prevedono disposizioni specifiche (1).
2. Possono altresì
essere immesse sul mercato italiano le sostanze in quanto tali o contenute in
preparati che sono state legittimamente notificate e immesse sul mercato in
altro Stato membro dell'Unione europea conformemente alle disposizioni
comunitarie.
----------
(1) Comma così
modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 25 febbraio 1998, n. 90.
Art.
6
(Obbligo
di ricerca)
1. I fabbricati, gli importatori
e i distributori di sostanze pericolose che non figurano ancora nell'allegato
I, ma sono incluse nell'EINECS, sono obbligati ad effettuare idonee ricerche
per conoscere i dati pertinenti ed accessibili esistenti per quanto riguarda le
proprietà di tali sostanze.
2. In base alle
informazioni acquisite ai sensi del comma 1, gli stessi soggetti di cui al
comma 1 devono imballare nonchè etichettare provvisoriamente tali sostanze
conformemente a quanto stabilito dagli articoli 19, 20, 21 e 22, nonchè dai
criteri di cui all'allegato VI (1).
3. Qualora per
determinate sostanze iscritte nell'EINECS siano stati ottenuti dati mediante
prove effettuate con metodi diversi da quelli definiti nell'allegato V, e
sorgano dubbi sulla classificazione provvisoria adottata dal fabbricante,
dall'importatore o dal distributore, fatto salvo quanto previsto dalla legge 23
dicembre 1978, n. 833, articolo 32, il Ministero della sanità convoca una
conferenza di servizi cui partecipano i Ministeri interessati all'attuazione
del presente decreto, per valutare se i dati sono adeguati per procedere alla
classificazione ed etichettatura ovvero se sono necessarie nuove prove da
effettuarsi conformemente ai metodi definiti dall'allegato V; tale valutazione
tiene anche conto dell'esigenza di ridurre al minimo le prove sugli animali
vertebrati (2).
----------
(1) Comma così
modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 febbraio 1998, n. 90.
(2) Comma così
modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 febbraio 1998, n. 90.
Art.
7
(Notifica
completa)
1. Il notificante di
una sostanza è tenuto a presentare, all'unità di notifica di cui all'articolo
27, una notifica comprendente:
a) un fascicolo
tecnico contenente le informazioni necessarie ed i dati disponibili per
valutare i rischi prevedibili, immediati o differiti, che la sostanza può
presentare per l'uomo e per l'ambiente; il fascicolo deve contenere almeno le
informazioni ed i risultati degli studi di cui all'allegato VII, parte A,
nonchè la descrizione dettagliata e completa degli studi effettuati e dei
metodi utilizzati o l'indicazione dei loro riferimenti bibliografici;
b) una dichiarazione
riguardante gli effetti negativi della sostanza, in relazione ai diversi
impieghi prevedibili;
c) la proposta di classificazione
e di etichettatura della sostanza ai sensi del presente decreto;
d) la proposta di
scheda informativa in materia di sicurezza, di cui all'articolo 25, solamente
per le sostanze pericolose;
e) l'eventuale
dichiarazione del fabbricante che abbia sede fuori dell'Unione europea che lo
designi, ai fini della notifica, come unico suo rappresentante nell'Unione
europea;
f) l'eventuale
motivata richiesta di non applicare, per giustificati motivi, alla notifica le
disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2, per un periodo non superiore ad
un anno a decorrere dalla data della stessa notifica.
2. Oltre alle
informazioni di cui sopra, il notificante può fornire all'unità di notifica una
propria valutazione del rischio reale o potenziale per l'uomo e per l'ambiente
secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.
3. Fatto salvo il
disposto dell'articolo 14, il notificante di una sostanza già notificata è
tenuto ad informare l'unità di notifica quando:
a) il quantitativo
della sostanza immesso sul mercato raggiunge 10 tonnellate all'anno per
fabbricante o 50 tonnellate complessive per fabbricante;
b) il quantitativo
della sostanza immesso sul mercato raggiunge 100 tonnellate all'anno per
fabbricante o 500 tonnellate complessive per fabbricante;
c) il quantitativo
della sostanza immesso sul mercato raggiunge 1.000 tonnellate all'anno per
fabbricante o 5.000 tonnellate complessive per fabbricante.
4. Nel caso di cui al
comma 3, lettera a), l'unità di notifica può esigere che talune o tutte le prove
o studi complementari di cui al livello 1 dell'allegato VIII siano realizzati
entro il termine da essa stabilito.
5. Nel caso di cui al
comma 3, lettera b), l'unità di notifica esige che siano realizzati, entro il
termine da essa stabilito, le prove e gli studi complementari di cui al livello
1 dell'allegato VIII; il notificante tuttavia può dimostrare che una
determinata prova o un determinato studio non è appropriato o che sarebbe
preferibile una prova o uno studio scientifico alternativo.
6. Nel caso di cui al
comma 3, lettera c), l'unità di notifica stabilisce un programma di prove o di
studi secondo le modalità di cui al livello 2 dell'allegato VIII, che il
notificante deve realizzare entro il termine stabilito.
7. Il notificante deve
trasmettere all'unità di notifica i risultati degli studi effettuati, sia
quando le prove complementari vengano realizzate volontariamente da parte dello
stesso notificante, che quando vengano realizzate ai sensi dei commi 4, 5 e 6.
Art.
8
(Notifica
semplificata)
1. Il notificante che
intenda immettere sul mercato una sostanza in quantitativi inferiori ad una
tonnellata all'anno per fabbricante è tenuto a presentare, all'unità di
notifica, una notifica comprendente:
a) un fascicolo
tecnico contenente le informazioni necessarie e i dati utili disponibili per
valutare i rischi prevedibili, immediati o differiti, che la sostanza può
presentare per l'uomo e per l'ambiente; il fascicolo deve contenere almeno le
informazioni ed i risultati degli studi di cui all'allegato VII, parte B;
b) una descrizione
dettagliata e completa degli studi realizzati e dei metodi utilizzati o dei
loro riferimenti bibliografici, qualora richiesto dall'unità di notifica;
c) le altre
informazioni di cui all'articolo 7, comma 1.
2. Il notificante può
limitarsi a fornire le informazioni di cui all'allegato VII, parte C, per il
fascicolo tecnico delle sostanze immesse sul mercato in quantitativi inferiori
a 100 kg all'anno per fabbricante, fatte salve le disposizioni dell'articolo
16, comma 1.
3. Il notificante,
qualora abbia presentato un fascicolo semplificato di notifica ai sensi del
comma 2, fornisce all'unità di notifica, prima che i quantitativi della
sostanza immessa sul mercato raggiungano cento chilogrammi all'anno per
fabbricante o prima che i quantitativi complessivi immessi sul mercato
raggiungano i cinquecento chilogrammi per fabbricante, le informazioni
complementari necessarie per completare il fascicolo tecnico conformemente
all'allegato VII, parte B.
4. Il notificante,
qualora abbia presentato un fascicolo semplificato di notifica ai sensi del
comma 1, presenta all'unità di notifica, prima che il quantitativo della
sostanza immessa sul mercato raggiunga una tonnellata all'anno per fabbricante
o prima che i quantitativi complessivi immessi sul mercato raggiungano le
cinque tonnellate per fabbricante, una notifica completa conformemente al
disposto dell'articolo 7.
5. Le sostanze
notificate ai sensi dei commi 1 e 2 debbono essere imballate ed etichettate
provvisoriamente secondo quanto prescritto dagli articoli 19, 20, 21 e 22; nel
caso in cui, in base ai dati disponibili, non sia possibile procedere
compiutamente all'etichettatura secondo quanto stabilito agli articoli 20, 21 e
22, l'etichetta deve contenere, oltre alle informazioni ottenute con le prove
già realizzate, l'avvertenza "Attenzione: sostanza non ancora
completamente sottoposta a test".
Art.
9
(Sostanze
già notificate)
1. Per le sostanze già
notificate il notificante è dispensato dal fornire le informazioni prescritte
agli articoli 7 e 8 per i fascicoli tecnici di cui agli allegati VII, parte A,
VII, parte B, VII, parte C, o VII, parte D, eccettuati i punti 1 e 2 degli
allegati stessi, limitatamente alle informazioni trasmesse da almeno dieci
anni.
Art.
10
(Immissione
sul mercato delle sostanze notificate)
1. In mancanza di
indicazioni contrarie da parte dell'unità di notifica, le sostanze che sono
state oggetto di una notifica conformemente all'articolo 7, comma 1, possono
essere immesse sul mercato non prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla
data in cui l'unità di notifica ha ricevuto un fascicolo conforme alle
disposizioni del presente decreto. Qualora, invece, l'unità di notifica ritenga
il fascicolo non conforme al presente decreto e lo comunichi al notificante
come previsto dall'articolo 16, comma 5, la sostanza non può essere immessa sul
mercato prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data in cui l'unità di
notifica ha ricevuto gli elementi che rendono la notifica conforme al presente
decreto.
2. In mancanza di
indicazioni contrarie da parte dell'unità di notifica, le sostanze che sono
state oggetto di una notifica ai sensi dell'articolo 8, comma 1 o comma 2,
possono essere immesse sul mercato non prima che siano trascorsi trenta giorni
dalla data in cui l'unità di notifica ha ricevuto un fascicolo conforme alle
disposizioni del presente decreto. Qualora, invece, l'unità di notifica ritenga
il fascicolo non conforme al presente decreto e lo comunichi al notificante,
come previsto dall'articolo 16, comma 7, la sostanza può essere immessa sul
mercato non prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data in cui l'unità
di notifica ha ricevuto gli elementi che rendono la notifica conforme al
presente decreto; tuttavia, se l'unità di notifica comunica al notificante, ai
sensi dell'articolo 16, comma 7, che l'integrazione rende la notifica conforme
al presente decreto, la sostanza può essere immessa sul mercato quindici giorni
dopo che l'unità di notifica ha ricevuto le informazioni supplementari.
Art.
11
(Quantitativi
per sostanze fabbricate
fuori
dall'Unione europea)
1. Qualora, per
sostanze fabbricate fuori dall'Unione europea, esista più di una notifica per
una sostanza prodotta dallo stesso fabbricante, il quantitativo annuo e cumulativo
immesso sul mercato comunitario è determinato dalla Commissione europea e
dall'unità di notifica sulla base delle informazioni presentate ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, dell'articolo 8, comma 1, e dell'articolo 14.
L'obbligo di effettuare prove supplementari ai sensi dell'articolo 7, commi 4,
5 e 6, ricade su tutti i notificanti (1).
----------
(1) Comma così
modificato dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 1998, n. 90.
Art.
12
(Polimeri)
1. La notifica dei
polimeri oltre ad essere conforme alle disposizioni di cui agli articoli 7,
comma 1, e 8, comma 1, deve rispettare le disposizioni specifiche indicate
nell'allegato VII, parte D.
Art.
13
(Deroghe)
1. Le disposizioni degli
articoli 7, 8, 14 e 15 non si applicano alle seguenti sostanze:
a) sostanze che
figurano nell'EINECS;
b) additivi e sostanze
impiegati esclusivamente negli alimenti per animali;
c) sostanze impiegate come
additivi nei prodotti alimentari e sostanze utilizzate esclusivamente come
aromi nei prodotti alimentari;
d) ingredienti attivi
utilizzati esclusivamente per le specialità medicinali ad uso umano ed a uso
veterinario, con esclusione dei prodotti chimici intermedi;
e) sostanze utilizzate
esclusivamente per altre categorie di prodotti per le quali esistono procedure
comunitarie di notifica o di omologazione e per le quali le prescrizioni
relative alle informazioni da presentare sono uguali a quelle previste dal
presente decreto. Tali sostanze sono quelle elencate in allegato A: con decreto
del Ministro della sanità si provvede ad integrare tale allegato in conformità
alle integrazioni disposte in sede comunitaria (1).
2. In deroga agli
articoli 7 e 8, si considerano notificate ai sensi del presente decreto
allorchè siano soddisfatte le relative condizioni, le seguenti sostanze:
a) i polimeri, ad
eccezione di quelli contenenti 2 per cento o più, in forma legata, di una
sostanza non inclusa nell'EINECS (2);
b) le sostanze immesse
sul mercato in quantitativi inferiori a dieci chilogrammi all'anno per
fabbricante a condizione che il fabbricante o l'importatore fornisca all'unità
di notifica le informazioni previste nell'allegato VII, parte C, punti 1 e 2;
c) le sostanze immesse
sul mercato in quantitativi non superiori ai cento chilogrammi all'anno per
fabbricante a condizione che siano destinate esclusivamente ad attività,
effettuate in condizioni controllate, di ricerca e di sviluppo scientifici;
d) le sostanze immesse
sul mercato e destinate all'attività di ricerca e di sviluppo finalizzati al
processo con un numero limitato di clienti registrati ed in quantitativi
esigui, corrispondenti alle esigenze della ricerca e dello sviluppo finalizzati
al processo, per il periodo di tempo e alle condizioni di cui al comma 5.
3. Il notificante che
si avvale della deroga di cui al comma 2, lettera c), deve tenere un registro
relativo all'identità della sostanza, ai dati utilizzati per l'etichettatura ed
alle quantità, nonchè un elenco dei clienti.
4. Le informazioni di
cui al comma 3 devono essere presentate su richiesta all'autorità di vigilanza
e all'unità di notifica.
5. La deroga di cui al
comma 2, lettera d), è valida per un anno, prorogabile in circostanze eccezionali
per non più di un ulteriore anno, su richiesta motivata dell'interessato, a
condizione che il fabbricante o l'importatore comunichi all'unità di notifica
la loro identità, i dati utilizzati per l'etichettatura, i quantitativi, la
giustificazione dei quantitativi, l'elenco dei clienti ed il programma di
ricerca e di sviluppo finalizzati al processo e si conformi alle eventuali
disposizioni impartite dalla stessa unità di notifica; tali disposizioni
possono prevedere informazioni comunque non eccedenti quelle previste
dall'articolo 8.
6. Il notificante che
si avvale della deroga di cui al comma 2, lettera d), è tenuto a garantire che
la sostanza o il preparato in cui la sostanza è incorporata venga manipolato
esclusivamente dal personale dei clienti in condizioni controllate e che non
siano mai messi a disposizione del pubblico, nè in quanto tali, nè in un
preparato. Allo scadere della deroga il notificante è tenuto a notificare le
sostanze che hanno beneficiato della deroga di cui al comma 5.
7. L'unità notifica,
ove reputi che possa sussistere un rischio inaccettabile per l'uomo e per
l'ambiente, può estendere la restrizione di cui al comma 6 a qualsiasi prodotto
contenente la nuova sostanza e fabbricato nel corso di una attività di ricerca
e di sviluppo finalizzati al processo.
8. Le sostanze di cui
al comma 2 devono essere imballate nonchè etichettate provvisoriamente dal
fabbricante stesso o dal suo rappresentante secondo quanto prescritto dagli
articoli 19, 20, 21 e 22 nonchè dai criteri di cui all'allegato VI; nel caso in
cui non sia possibile etichettare tali sostanze conformemente agli articoli 20,
21 e 22, non essendo disponibili tutti i risultati delle prove di cui
all'allegato VII, parte A, l'etichetta deve recare, oltre alle informazioni
ottenute con le prove già realizzate, la seguente avvertenza: "Attenzione:
sostanza non ancora completamente sottoposta a test".
9. Nel caso in cui una
delle sostanze di cui al comma 2 risulti, sulla base delle conoscenze
disponibili, molto tossica, tossica, cancerogena, tossica per il ciclo
riproduttivo o mutagena, il notificante deve comunicare all'unità di notifica
tutte le informazioni di cui all'allegato VII, parte A, punti 2.3, 2.4 e 2.5 e
fornire, ove disponibili, i dati relativi alla tossicità acuta.
----------
(1) Lettera così
modificata dall'art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 febbraio 1998, n. 90.
(2) Lettera così
sostituita dall'art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 febbraio 1998, n. 90.
Art.
14
(Aggiornamento
delle informazioni)
1. Il notificante di
una sostanza già notificata conformemente all'articolo 7, comma 1, o
all'articolo 8, comma 1, è tenuto ad informare per iscritto l'unità di
notifica:
a) dei cambiamenti nei
quantitativi annui e in quelli complessivi che ha immesso sul mercato o, nel
caso di una sostanza fabbricata fuori dell'Unione europea per la quale il
notificante è stato designato come unico rappresentante, che egli o altri hanno
immesso sul mercato comunitario;
b) delle nuove
conoscenze circa gli effetti della sostanza sull'uomo e sull'ambiente che egli
abbia acquisito o avrebbe potuto acquisire;
c) dei nuovi impieghi
per i quali la sostanza viene immessa sul mercato e di cui il notificante abbia
acquisito o avrebbe potuto acquisire conoscenza;
d) di ogni modifica
nella composizione della sostanza, ai sensi del punto 1.3 degli allegati VII,
parte A, VII, parte B o VII, parte C;
e) di ogni cambiamento
della sua qualifica di fabbricante o di importatore.
2. L'importatore di
una sostanza prodotta da un fabbricante stabilito fuori dell'Unione europea,
che importi detta sostanza nell'ambito di una notifica presentata in precedenza
da un rappresentante unico, è tenuto ad accertarsi che il rappresentante unico
disponga di informazioni aggiornate sui quantitativi della sostanza da lui
immessi sul mercato comunitario.
3. L'immissione in
commercio della sostanza in assenza dell'aggiornamento di cui al presente
articolo è considerata immissione in commercio di sostanza non notificata.
Art.
15
(Notifiche
successive - Norme intese ad evitare la ripetizione
di
esperimenti su animali vertebrati)
1. Per le sostanze già
notificate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, o dell'articolo 8, comma 1,
l'unità di notifica accetta che il notificante successivo della stessa sostanza
faccia riferimento, per quanto concerne i punti 3, 4 e 5 dell'allegato VII,
parte A, e dell'allegato VII, parte B, nonchè i punti 3 e 4 dell'allegato VII,
parte C, ai risultati degli esperimenti o degli studi comunicati dal primo
notificante, purchè il notificante successivo dimostri che la sostanza in
questione corrisponde a quella notificata in precedenza, anche per quanto
riguarda il grado di purezza e la natura delle impurezze; il riferimento ai
risultati delle prove o degli studi comunicati dal primo notificante è
consentito soltanto con l'accordo scritto di quest'ultimo.
2. Prima di effettuare
esperimenti su animali vertebrati ai fini della presentazione della notifica di
cui all'articolo 7, comma 1, o all'articolo 8, comma 1, i notificanti
successivi, fatto salvo quanto previsto al comma 1, debbono chiedere all'unità
di notifica le seguenti informazioni:
a) se la sostanza che
intendono notificare abbia già formato oggetto di notifica;
b) il nome e
l'indirizzo del primo notificante.
3. Nella richiesta di
cui al comma 2 il notificante deve dichiarare che intende immettere la sostanza
sul mercato e specificarne i relativi quantitativi.
4. L'unità di notifica
fornisce al notificante successivo il nome e l'indirizzo del primo notificante
e trasmette al primo notificante il nome e indirizzo del notificante successivo
solo se concorrono le seguenti condizioni:
a) il notificante
successivo ha comprovato la sua intenzione di immettere la sostanza sul mercato
nei quantitativi indicati;
b) la sostanza ha già
formato oggetto di notifica;
c) il primo
notificante non ha chiesto nè ha ottenuto una deroga temporanea alle
disposizioni del presente articolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera
f).
5. Il primo notificante
ed il notificante successivo si adoperano per raggiungere un accordo sullo
scambio di informazioni, per evitare la ripetizione degli esperimenti su
animali vertebrati.
6. I notificanti di
una stessa sostanza che hanno concordato di scambiarsi le informazioni relative
all'allegato VII, parte A. ai sensi dei commi precedenti si adoperano inoltre
per raggiungere un accordo sullo scambio delle informazioni desunte dalle prove
su animali vertebrati da effettuarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 4, 5 e 6.
7. Con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate, per i casi di
mancato accordo tra le parti interessate, le modalità della messa in comune
delle informazioni di cui ai commi 5 e 6 e la procedura di utilizzazione delle
stesse, assicurando un ragionevole equilibrio fra gli interessi delle parti.
Art.
16
(Valutazione
del fascicolo notificato)
1. L'unità di
notifica, nell'ambito dell'esame di conformità della documentazione pervenuta
per la notifica di nuove sostanze, può,
qualora sia necessario per valutare i rischi di una determinata sostanza,
chiedere informazioni complementari, prove supplementari o prove di verifica e
di conferma che abbiano per oggetto le sostanze o i relativi prodotti di
trasformazione; in particolare le informazioni di cui all'allegato VIII possono
essere richieste prima del raggiungimento delle quantità previste dall'articolo
7, comma 3.
2. L'unità di
notifica, oltre a quanto previsto al comma 1, può:
a) chiedere il
prelievo dei campioni necessari a scopi di controllo secondo le modalità di cui
all'articolo 28;
b) chiedere al
notificante di fornire le quantità della sostanza notificata che essa ritiene
necessaria ai fini delle prove di verifica;
c) chiedere l'adozione
di misure appropriate in materia di sicurezza di impiego, in mancanza di
disposizioni comunitarie.
3. Per le sostanze
notificate conformemente all'articolo 7, comma 1, ed all'articolo 8, commi 1 e
2, l'unità di notifica effettua una valutazione dei rischi secondo i principi
di cui al Capo IV, ed indica eventuali raccomandazioni sul metodo più
appropriato per le prove relative ad una determinata sostanza e le misure da
adottare per ridurre i rischi, per l'uomo e per l'ambiente, connessi con la
commercializzazione della sostanza.
4. La valutazione di
cui al comma 3 viene aggiornata in base alle informazioni supplementari fornite
ai sensi del presente articolo o dell'articolo 7, commi 4, 5 e 6, dell'articolo
8, comma 3, e dell'articolo 14, comma 1.
5. Per le notifiche
presentate ai sensi dell'articolo 7, l'unità di notifica, entro il termine di
sessanta giorni dal ricevimento, comunica per iscritto al notificante se la
notifica è stata riconosciuta conforme o non conforme al presente decreto.
6. Nel caso in cui il
fascicolo sia stato accettato, in quanto ritenuto conforme, l'unità di notifica
comunica al notificante anche il numero ufficiale che è stato attribuito alla
notifica; in caso contrario, la stessa unità di notifica comunica al
notificante quali ulteriori informazioni siano necessarie per rendere il
fascicolo conforme al presente decreto.
7. Per le notifiche
presentate ai sensi dell'articolo 8, l'unità di notifica, entro il termine di
trenta giorni dal ricevimento della notifica, decide se il fascicolo è conforme
al presente decreto e, in caso negativo, comunica al notificante quali
ulteriori informazioni siano necessarie per renderlo conforme; quando il
fascicolo è ritenuto conforme, l'unità di notifica comunica al notificante,
entro trenta giorni dal ricevimento del fascicolo o delle informazioni
supplementari, il numero ufficiale che è stato attribuito alla notifica.
8. Per le sostanze
fabbricate fuori dall'Unione europea per le quali è stata presentata più di una
notifica per una sostanza prodotta dallo stesso fabbricante, l'unità di
notifica, d'intesa con le altre autorità competenti e con la Commissione
europea, effettua il calcolo del quantitativo annuo e di quello complessivo
immesso sul mercato comunitario; nel caso in cui vengano raggiunti i
quantitativi massimi indicati nell'articolo 7, comma 3, l'unità di notifica
informa il notificante della identità degli altri notificanti ed avvisa tutti i
notificanti circa le loro responsabilità collettive di cui all'articolo 11.
9. L'unità di
notifica, ricevuti i fascicoli di notifica di cui all'articolo 7, comma 1, ed
all'articolo 8, comma 1, le informazioni sulle prove complementari effettuate
in conformità dell'articolo 7, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 8, commi 3 e 4,
ovvero le informazioni successive presentate in applicazione dell'articolo 14,
trasmette alla Commissione europea copia del fascicolo o delle informazioni
successive oppure il relativo riassunto.
10. Per quanto
concerne le informazioni complementari di cui al comma 1, l'unità di notifica
comunica alla Commissione europea le prove scelte, le motivazioni di tale
scelta, i risultati ed eventualmente la valutazione degli stessi. Per quanto
riguarda le informazioni ricevute a norma dell'articolo 14, l'unità di notifica
trasmette alla Commissione europea gli elementi che presentano interesse comune
per la Commissione stessa e per le altre autorità competenti.
11. L'unità di
notifica trasmette alla Commissione europea, non appena possibile, la
valutazione dei rischi di cui al comma 3, o una sintesi della stessa (1).
----------
(1) Comma così
modificato dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 1998, n. 90.
Art.
17
(Riservatezza
delle informazioni)
1. Nel caso in cui il
notificante ritiene che la diffusione delle informazioni potrebbe danneggiarlo
sul piano industriale o commerciale, può specificare quali delle informazioni
di cui agli articoli 7, 8 e 14 richiedano un trattamento riservato ed esigano
pertanto che sia mantenuto il segreto nei confronti di altre persone che non
siano le autorità competenti e la Commissione europea. In tale caso debbono
essere fornite le relative giustificazioni.
2. Il segreto industriale
e commerciale per quanto riguarda le notifiche e le informazioni trasmesse in
applicazione dell'articolo 7, commi 1 e 2, nonchè dell'articolo 8, commi 1, 2 e
3, non può essere applicato:
a) alla denominazione
commerciale della sostanza;
b) al nome del
fabbricante e del notificante;
c) ai dati
fisico-chimici della sostanza previsti dall'allegato VII;
d) ai possibili mezzi
per rendere innocua la sostanza;
e) alla sintesi dei
risultati delle prove tossicologiche ed ecotossicologiche (1);
f) al grado di purezza
della sostanza ed all'identità delle impurezze o degli additivi che sono
pericolosi, qualora tali dati siano indispensabili ai fini della
classificazione e dell'etichettatura ed ai fini dell'inserimento della sostanza
nell'allegato I;
g) ai metodi ed alle
precauzioni raccomandati di cui al punto 2.3 ed alle misure di emergenza di cui
ai punti 2.4 e 2.5 delle parti A, B e C dell'allegato VII;
h) alle informazioni
contenute nella scheda informativa in materia di sicurezza;
i) ai metodi analitici
che consentono di individuare la sostanza pericolosa una volta immessa
nell'ambiente e di determinare l'esposizione umana diretta alla stessa
sostanza, nel caso di sostanze dell'allegato I.
3. Il notificante, nel
caso in cui renda successivamente pubbliche le informazioni prima riservate,
deve informarne l'unità di notifica.
4. L'unità di notifica
sulla base delle indicazioni ricevute:
a) decide quali
informazioni sono protette dal segreto industriale e commerciale, conformemente
ai commi 1, 2 e 3; tali informazioni devono essere mantenute segrete ed essere
comunicate alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione
europea;
b) può stabilire che
siano indicate soltanto con la denominazione commerciale, per un periodo
massimo di tre anni; le sostanze notificate comprese nell'elenco di cui
all'articolo 18 e non classificate pericolose; tuttavia, se ritiene che la
pubblicazione della denominazione chimica prevista dalla nomenclatura IUPAC
(Unione Internazionale di Chimica Pura ed Applicata) possa rivelare
informazioni in merito allo sfruttamento commerciale o alla fabbricazione della
sostanza, può disporre che la stessa venga registrata con la sola denominazione
commerciale per un periodo superiore a tre anni.
5. L'unità di notifica
può richiedere alla Commissione europea che le sostanze pericolose siano
riportate nell'elenco di cui all'articolo 18 con la sola denominazione
commerciale sino al loro inserimento nell'allegato I.
6. Le informazioni
riservate comunicate all'unità di notifica dalle autorità competenti degli
altri Stati membri sono mantenute segrete.
7. Tutte le
informazioni riservate possono essere comunicate alle persone direttamente
coinvolte in procedimenti amministrativi o giudiziari, comportanti sanzioni,
avviati con l'obiettivo di controllare le sostanze immesse sul mercato nonchè
alle persone che devono prendere parte o essere ascoltate nell'ambito
dell'esercizio dei poteri di informazione, vigilanza e controllo del
Parlamento.
----------
(1) Lettera così modificata
dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 1998, n. 90.
Art.
18
(Elenco
delle sostanze)
1. Il Ministero della
sanità cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dell'elenco delle sostanze notificate, complete del numero CE, compilato dalla
Commissione europea.
Art.
19
(Imballaggio)
1. L'imballaggio delle
sostanze pericolose deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) l'imballaggio deve
essere progettato e realizzato in modo tale da impedire qualsiasi fuoriuscita
del contenuto, fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni che
prescrivono speciali dispositivi di sicurezza;
b) i materiali che
costituiscono l'imballaggio e la chiusura non devono essere suscettibili di
deteriorarsi a causa del contenuto, nè poter formare con questo composti
pericolosi;
c) tutte le parti
dell'imballaggio e della chiusura devono essere solide e robuste, in modo da
escludere qualsiasi allentamento e sopportare in maniera affidabile le normali
sollecitazioni della manipolazione;
d) il recipiente
munito di un sistema di chiusura che può essere riapplicato deve essere
progettato in modo che l'imballaggio possa essere richiuso ripetutamente senza
fuoriuscita del contenuto;
e) qualsiasi
recipiente, di qualsiasi capacità, che contenga sostanze vendute o disponibili
al dettaglio e sia etichettato come "molto tossico", o
"tossico" o "corrosivo" ai sensi del presente decreto, deve
essere dotato di una chiusura di sicurezza per la protezione dei bambini e
recare un'indicazione di pericolo avvertibile al tatto;
f) qualsiasi
recipiente, di qualsiasi capacità, che contenga sostanze vendute o disponibili
al dettaglio e sia etichettato come "nocivo", "estremamente
infiammabile" o "facilmente infiammabile" ai sensi del presente
decreto deve recare un'indicazione di pericolo avvertibile al tatto.
2. Le specifiche
tecniche relative ai dispositivi ed ai sistemi di sicurezza di cui al comma 1,
lettere e) e f), sono indicate nell'allegato IX.
Art.
20
(Etichettatura)
1. L'etichettatura delle
sostanze pericolose deve recare in caratteri leggibili e indelebili:
a) la denominazione
della sostanza conforme a una della denominazioni riportate nell'allegato I. Se
la sostanza non figura nell'allegato I, la denominazione deve basarsi su una
nomenclatura internazionalmente riconosciuta;
b) il nome e
l'indirizzo completo nonchè il numero di telefono del responsabile
dell'immissione sul mercato stabilito all'interno dell'Unione europea, che può
essere il fabbricante, l'importatore o il distributore;
c) i simboli di
pericolo, se previsti, e l'indicazione di pericolo che comporta l'impiego della
sostanza. I simboli e le indicazioni di pericolo devono essere conformi
all'allegato II ed essere stampati in nero su fondo giallo-arancione. I simboli
e le indicazioni di pericolo da usare per ciascuna sostanza sono quelli
riportati nell'allegato I. Alle sostanze pericolose non ancora contenute
nell'allegato I, i simboli e le indicazioni di pericolo sono assegnati in base
alle norme dell'allegato VI. Quando ad una sostanza sono assegnati più simboli,
salvo disposizioni contrarie riportate in allegato I, l'obbligo di apporre il
simbolo T rende facoltativi i simboli X e C, l'obbligo di apporre il simbolo C
rende facoltativo il simbolo X, l'obbligo di apporre il simbolo E rende
facoltativi i simboli F e O;
d) le frasi tipo
relative ai rischi specifici derivanti dai periodi dell'uso della sostanza,
dette "frasi R". Esse devono essere formulate secondo le modalità
dell'allegato III. Quelle da usare per ciascuna sostanza sono riportate
nell'allegato I. Per le sostanze pericolose non ancora contenute nell'allegato
I, le "frasi R" da usare sono assegnate in base alle norme
dell'allegato VI;
e) le frasi tipo
concernenti consigli di prudenza relativi all'uso della sostanza, dette
"frasi S". Esse devono essere formulate secondo le modalità
dell'allegato VI. Quelle da usare per ciascuna sostanza sono riportate
nell'allegato I. Per le sostanze pericolose non ancora contenute nell'allegato
I, le "frasi S" da usare sono assegnate in base alle norme
dell'allegato VI;
f) il numero CE, se
assegnato, desunto dall'EINECS o dall'elenco di cui all'articolo 18;
g) l'indicazione
"Etichetta CE" per le sostanze contenute nell'allegato I.
2. Per le sostanze
irritanti, facilmente infiammabili, infiammabili o comburenti, non è necessaria
l'indicazione delle relative "frasi R" e "frasi S" se il
contenuto dell'imballaggio non supera i 125 millilitri. Lo stesso vale per le
sostanze nocive che, in imballaggi di pari contenuto, non sono vendute al
consumatore.
3. Indicazioni quali
"non tossico", "non nocivo" o qualsiasi altra analoga non
devono figurare sull'etichetta o sull'imballaggio delle sostanze che rientrano
nell'ambito del presente decreto.
Art.
21
(Attuazione
delle norme di etichettatura)
1. Se le diciture di
cui all'articolo 20 figurano su un'etichetta, questa deve essere solidalmente
apposta su uno o più lati dell'imballaggio, in modo da consentire la lettura
orizzontale quando l'imballaggio si trova in posizione normale. Le dimensioni e
le caratteristiche delle etichette debbono corrispondere alle prescrizioni di
cui alla Tabella A.
2. L'etichetta non è
necessaria quando l'imballaggio stesso reca, ben visibili, le indicazioni
richieste, secondo le modalità di cui al comma 1.
3. Il colore e la
presentazione dell'etichetta o dell'imballaggio, nel caso di cui al comma 2,
devono essere tali da far risaltare con chiarezza il simbolo di pericolo col
suo fondo.
4. Le informazioni da
apporre sull'etichetta, conformemente all'articolo 20, devono risaltare sullo
sfondo e la loro dimensione e spaziatura devono essere sufficienti per
consentire un'agevole lettura. Il Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente
stabilisce, in conformità alla normativa comunitaria, le disposizioni
specifiche riguardanti la presentazione ed il formato delle informazioni di cui
al presente comma.
5. Le indicazioni di cui
all'articolo 20 devono essere in lingua italiana; qualora siano redatte in più
lingue, quelle in lingua italiana non devono essere di caratteri inferiori a
quelli delle altre lingue.
6. I requisiti di
etichettatura previsti dal presente decreto si considerano soddisfatti:
a) se si tratta di
imballaggi esterni che racchiudono uno o più imballaggi interni, quando
l'imballaggio esterno è provvisto di un'etichettatura conforme ai regolamenti
internazionali relativi al trasporto delle merci pericolose e l'imballaggio o
gli imballaggi interni sono provvisti di un'etichettatura conforme al presente
decreto;
b) se si tratta di un
imballaggio unico, quando l'imballaggio è provvisto di un'etichettatura
conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle merci
pericolose ed all'articolo 20, comma 1, lettere a), b), d), e) ed f) e, per
tipi particolari di imballaggio, quali le bombole mobili per i gas, conforme
alle disposizioni dell'allegato VI.
Art.
22
(Deroghe
alle norme di etichettatura e di imballaggio)
1. Gli articoli 19, 20
e 21 non si applicano alle munizioni ed agli esplosivi immessi sul mercato allo
scopo di produrre esplosioni o effetti pirotecnici, per i quali restano ferme
le disposizioni vigenti in materia, nè fino al 30 aprile 1997, al propano ed al
gas di petrolio liquefatto.
2. Quando gli
imballaggi sono di dimensione ridotta o sono altrimenti inadatti per consentire
un'etichettatura conforme alle dimensioni ed alle modalità applicative di cui agli
articoli 20 e 21, commi 1 e 2, l'etichetta può essere realizzata in dimensioni
ridotte; la superficie dell'etichetta non può comunque essere inferiore a 10
centimetri quadrati ed il simbolo deve misurare almeno un centimetro quadrato.
3. Nel caso in cui
risulti materialmente impossibile effettuare un'etichettatura conforme alle
modalità applicative di cui al comma 2, il Ministro della sanità, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il
Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
stabilisce le caratteristiche cui deve corrispondere l'etichetta.
4. Il Ministro della
sanità stabilisce altresì, con le stesse modalità, in deroga agli articoli 20 e
21, i casi in cui gli imballaggi delle sostanze che non sono esplosive, molto
tossiche o tossiche, possono non essere etichettati o possono essere
etichettati in modo diverso quando contengano quantitativi talmente limitati da
non comportare alcun pericolo sia per le persone che manipolano tali sostanze
che per terzi.
Art.
23
(Pubblicità)
1. E' vietata la
pubblicità delle sostanze che appartengono ad una o più delle categorie
previste all'articolo 2, comma 2, qualora la pubblicità stessa non indichi la
categoria o le categorie di appartenenza della sostanza.
Art.
24
(Tariffe
per la notifica)
1. Le spese relative
all'espletamento dell'istruttoria per la verifica delle notifiche di cui agli
articoli 7 e 8 sono poste a carico dei notificanti.
2. Con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinate ed
aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività di cui agli
articoli 7 e 8, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi e del valore
economico delle prestazioni effettuate, nonchè le modalità di riscossione delle
tariffe medesime.
3. I proventi
derivanti dall'applicazione degli articoli 7 e 8 sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreti del Ministro
del tesoro, allo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.
Una parte di detti proventi è destinata ai controlli di cui all'articolo 28 e
la parte rimanente versata al bilancio dell'Istituto superiore di sanità, per
il funzionamento dei servizi preposti all'espletamento delle attività di cui
agli articoli 7 e 8.
Art.
25
(Scheda
informativa in materia di sicurezza)
1. Per consentire agli
utilizzatori professionali di prendere le misure necessarie per la protezione
dell'ambiente, nonchè della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, il
fabbricante, l'importatore o il distributore che immette sul mercato una
sostanza pericolosa deve fornire gratuitamente, su supporto cartaceo o per via
elettronica, al destinatario della sostanza stessa, una scheda informativa in
materia di sicurezza in occasione o anteriormente alla prima fornitura; egli è
tenuto altresì a trasmettere, ove sia venuto a conoscenza di ogni nuova
informazione al riguardo, una scheda aggiornata.
2. La scheda di cui al
comma 1 deve essere redatta in lingua italiana, nell'osservanza delle
disposizioni da adottarsi con decreto del Ministro della sanità entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, in conformità alle
direttive comunitarie; la scheda deve riportare, come informazione, la data di
compilazione e dell'eventuale aggiornamento (1).
----------
(1) Comma così
modificato dall'art. 10, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 1998, n. 90.
Capo III
MISURE PROCEDURALI E ORGANIZZATIVE
Art.
26
(Commissione
consultiva)
1. Presso il Ministero
della sanità è istituita una
Commissione consultiva composta dai seguenti membri o dai loro
sostituti:
a) il dirigente generale
del dipartimento prevenzione del Ministero della sanità che la presiede;
b) un rappresentante
del Ministero della sanità esperto di problematiche concernenti la
classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di sostanze pericolose;
c) un rappresentante
dell'unità di notifica;
d) due rappresentanti
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui uno
esperto di problematiche di produzione industriale ed uno esperto di
problematiche di tutela dei consumatori;
e) due rappresentanti
del Ministero dell'interno, di cui uno esperto di problematiche di pubblica
sicurezza ed uno di problematiche di protezione civile e sicurezza antincendi;
f) un rappresentante
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale esperto di problematiche
inerenti la sicurezza nell'ambiente di lavoro;
g) due rappresentanti
del Ministero dell'ambiente, di cui uno esperto in problematiche sui rischi per
l'ambiente ed uno esperto di problematiche sulla tutela del suolo;
h) un rappresentante
del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esperto
di problematiche connesse con la ricerca scientifica;
i) un rappresentante
del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali esperto in
problematiche di produzione agricola.
2. Per lo svolgimento
dei lavori, la Commissione può organizzarsi in sottogruppi ed avvalersi
dell'opera di Enti o di istituti pubblici di ricerca e di esperti secondo la
legislazione vigente.
3. Le funzioni di
segreteria sono svolte a cura del Ministero della sanità.
4. I componenti la
Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
5. La Commissione
consultiva:
a) esprime pareri su
problematiche inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi nonchè su quelle in
discussione in sede comunitaria ed internazionale;
b) esprime pareri
sulle eventuali richieste specifiche sottopostele dall'unità di notifica;
c) esprime pareri
sulle richieste specifiche sottopostele dal Ministero della sanità anche a
seguito di richieste avanzate dai notificanti in relazione alle decisioni
assunte dall'unità di notifica;
d) promuove, ove lo
ritenga necessario, la richiesta del parere del Consiglio superiore di sanità,
della Commissione consultiva tossicologica nazionale o di altro Ente o istituto
di ricerca pubblico.
6. Con regolamento
interno, da emanarsi con decreto del Ministro della sanità entro tre mesi dalla
data di pubblicazione del presente decreto, sono disciplinate le modalità
procedurali ed organizzative della Commissione.
7. La Commissione di
cui al comma 1 sostituisce quella prevista all'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927.
Art.
27
(Unità
di notifica)
1. Presso l'Istituto
superiore di sanità è istituita, nell'ambito della dotazione organica esistente
e delle ordinarie risorse di bilancio, l'unità di notifica che, per
l'espletamento dei compiti relativi alla notifica di nuove sostanze, si avvale,
di volta in volta, di esperti dell'Istituto superiore di sanità in materia di
tossicologia, mutagenesi, cancerogenesi, tossicità per la riproduzione,
proprietà fisico-chimiche, proprietà ecotossicologiche e inventario nazionale
delle sostanze chimiche, nonchè, senza oneri a carico del bilancio dello Stato,
di rappresentanti dei Ministeri della sanità, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dell'ambiente.
2. L'unità di
notifica:
a) esamina le
notifiche di cui agli articoli 7 e 8;
b) esprime parere
sulle proposte di classificazione ed etichettatura, nonchè sulle proposte di
raccomandazioni per la sicurezza di impiego delle sostanze notificate;
c) agisce come
autorità competente nazionale per il sistema comunitario di notifica delle
nuove sostanze chimiche;
d) promuovere, ove lo
ritenga necessario, per il tramite del Ministero della sanità, la richiesta del
parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 26;
e) informa, almeno
semestralmente, dell'attività svolta, la Commissione consultiva di cui
all'articolo 26.
Art.
28
(Controlli)
1. Al fine dell'accertamento
dell'osservanza delle norme del presente decreto, l'immissione sul mercato e la
commercializzazione delle sostanze pericolose sono soggette alla vigilanza
degli uffici competenti, in base alle vigenti disposizioni, delle
Amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli Enti locali; a tal fine il
relativo personale può procedere in qualunque momento ad ispezioni presso
luoghi di produzione, deposito e vendita, richiedere dati, informazioni e
documenti, prelevare campioni in numero massimo di tre a titolo gratuito,
sigillati all'atto del prelievo, e ciascuno in quantità sufficiente per una
analisi completa.
2. Nei casi di
constatata infrazione alle norme del presente decreto, il Ministero della
sanità, in ambito nazionale, e i competenti uffici delle regioni e degli Enti
locali, nell'ambito del territorio di rispettiva competenza, dispongono il
divieto di commercializzazione ed il sequestro in via amministrativa delle
merci a cura e comunque a spese del trasgressore, adottando le necessarie
prescrizioni per il loro ritiro e la loro custodia, garantendo la sicurezza
degli operatori, della popolazione e dell'ambiente. I provvedimenti adottati
dalle regioni e dagli Enti locali sono portati tempestivamente a conoscenza del
Ministero della sanità, che procede ai necessari accertamenti ai fini
dell'eventuale estensione delle misure all'intero territorio nazionale.
3. In caso di
immediato o grave pericolo per la salute o la sicurezza, le autorità di cui al
comma 2 possono immediatamente adottare le misure provvisorie necessarie, ivi
incluso il divieto di commercializzazione e il ritiro dal mercato.
4. Le misure di cui ai
commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui l'interessato non consenta agli
uffici di cui al comma 1 la tempestiva acquisizione dei campioni e dei
documenti di cui allo stesso comma.
5. Su richiesta della
ditta interessata, il Ministero della sanità può consentire l'adeguamento del
prodotto alle disposizioni del presente decreto ai fini del successivo
dissequestro.
6. I soggetti che, ai
sensi del comma 1, effettuano ispezioni e prelievi di campioni nell'esercizio
delle funzioni loro demandate, sono tenuti agli obblighi di riservatezza
relativamente alle informazioni acquisite, in conformità alle norme vigenti.
Art.
29
(Esami
e analisi di campioni)
1. Gli esami e le
analisi dei campioni prelevati dalle autorità locali sono eseguiti dai
laboratori competenti per territorio.
2. Quando dall'analisi
risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dal presente decreto,
il direttore del laboratorio trasmette immediata denuncia all'autorità
competente, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi.
Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
comunica all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo i risultati
dell'analisi. Analoga comunicazione è fatta al fabbricante, all'importatore o
al distributore nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni
originali; entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
gli interessati possono presentare alla autorità che ha disposto il prelievo
istanza di revisione di analisi.
3. Le analisi di
revisione sono eseguite presso l'Istituto superiore di sanità entro i termini
fissati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
4. L'Istituto
superiore di sanità avverte, con congruo anticipo, l'interessato, mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del giorno, dell'ora e del
luogo in cui avranno inizio le operazioni di revisione; l'interessato ha
diritto di farsi assistere, nelle dette operazioni, dal suo difensore o da un
consulente tecnico.
5. In caso di mancata
presentazione nei termini della istanza di revisione e nel caso che l'analisi
di revisione confermi quella di prima istanza, l'autorità competente trasmette
denuncia alla autorità giudiziaria e ne informa il Ministero della sanità.
6. Gli esami e le
analisi dei campioni prelevati dalle autorità centrali sono eseguiti
dall'Istituto superiore di sanità, il quale trasmette il proprio parere,
corredato dai risultati e con l'indicazione delle eventuali misure ritenute
opportune, al Ministero della sanità, per l'adozione dei provvedimenti di
competenza.
7. In caso di
immediato o grave pericolo per la salute o la sicurezza, le autorità di cui
all'articolo 28, comma 2, possono immediatamente adottare le misure provvisorie
necessarie, ivi incluso il divieto di commercializzazione e l'ordine di ritiro
dal mercato; ai fini dell'eventuale revoca di tali misure si applica la
procedura di cui ai commi 3 e 4.
Capo IV
VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE
Art.
30
(Definizioni
ai fini della valutazione del rischio)
1. Ai fini del
presente decreto si intende per:
a) identificazione del
pericolo: l'identificazione degli effetti dannosi che una determinata sostanza
può causare per la sua natura intrinseca;
b) valutazione del
rapporto tra dose o concentrazione e risposta o effetto: la valutazione del
rapporto tra la dose o il livello di esposizione ad una data sostanza e
l'incidenza e la gravità del suo effetto;
c) valutazione
dell'esposizione: la determinazione delle emissioni, vie e velocità di
spostamento di una data sostanza e della sua trasformazione o degradazione al
fine di stimare la concentrazione o la dose alla quale la popolazione o i
comparti ambientali sono o possono essere esposti;
d) caratterizzazione
del rischio: la stima dell'incidenza e della gravità degli effetti dannosi che
possono manifestarsi in una popolazione o in un comparto ambientale dovuti ad
una esposizione effettiva o prevista ad una determinata sostanza; essa può
comprendere la stima del rischio, vale a dire la quantificazione di questa
probabilità;
e) raccomandazione per
la riduzione del rischio: la raccomandazione delle misure che possono ridurre i
rischi per l'uomo e per l'ambiente in rapporto alla commercializzazione della
sostanza in questione; dette raccomandazioni possono includere:
1) modifiche della
classificazione, dell'imballaggio o dell'etichettatura della sostanza proposta
nella notifica;
2) modifiche della
scheda di dati di sicurezza proposta nella notifica;
3) modifiche proposte
dal notificante nel fascicolo tecnico allegato alla notifica, dei metodi
raccomandati e delle precauzioni o delle misure di emergenza indicati ai punti
2.3, 2.4 e 2.5 degli allegati VII, parte A, VII, parte B, o VII, parte C;
4) una raccomandazione
alle autorità di controllo competenti di considerare misure opportune per la
protezione dell'uomo e dell'ambiente contro i rischi individuati.
Art.
31
(Principi
della valutazione del rischio)
1. La valutazione del
rischio comporta l'identificazione del pericolo e, se del caso, la valutazione
del rapporto tra dose o concentrazione e risposta o effetto, la valutazione dell'esposizione
e la caratterizzazione del rischio. In linea generale tale valutazione si
svolge secondo le procedure stabilite negli articoli 32 e 33.
2. Fatto salvo il
comma 1, in caso di effetti particolari, quali la riduzione della fascia di
ozono, ai quali non possono applicarsi le procedure previste negli articoli 32
e 33, la connessa valutazione dei rischi si effettua caso per caso e l'unità di
notifica descrive e motiva in maniera circostanziata tale valutazione nella
relazione scritta che essa presenta alla Commissione secondo il disposto
dell'articolo 35.
3. Nella valutazione
dell'esposizione, l'unità di notifica tiene conto delle popolazioni e dei
comparti ambientali la cui esposizione alla sostanza è ragionevolmente
prevedibile alla luce delle informazioni disponibili sulla sostanza in
questione, in particolare prendono in considerazione elementi quali la
conservazione, la formulazione in un preparato e altre forme di lavorazione,
l'utilizzazione e l'eliminazione o il riciclaggio della sostanza stessa.
4. Nella formulazione
delle raccomandazioni per la riduzione del rischio di una data sostanza,
l'unità di notifica tiene conto dell'eventualità che la riduzione
dell'esposizione di una data categoria della popolazione o di un determinato comparto
ambientale possa comportare l'aumento dell'esposizione di un'altra categoria di
popolazione e di altri comparti ambientali.
Art.
32
(Valutazione
del rischio relativo alla salute umana)
1. Per ciascuna
sostanza notificata, l'unità di notifica procede ad una valutazione del rischio
relativo all salute umana, la cui prima fase consiste nell'identificazione del
pericolo e comprende almeno l'individuazione delle proprietà e degli effetti
dannosi potenziali specificati nelle tabelle B, parte A, e C, parte A. Dopo
aver identificato il pericolo, l'unità di notifica procede secondo i principi
stabiliti nelle tabelle B, parte B, e C, parte B:
a) alla eventuale
valutazione del rapporto tra dose o concentrazione e risposta o effetto;
b) alla valutazione
dell'esposizione per tutte le categorie di popolazioni potenzialmente esposte
alla sostanza in questione, quali i lavoratori, i consumatori e l'uomo esposto
indirettamente attraverso l'ambiente;
c) alla
caratterizzazione del rischio.
Art.
33
(Valutazione
del rischio relativo all'ambiente)
1. Per ciascuna
sostanza notificata, l'unità di notifica procede ad una valutazione del rischio
sugli effetti della sostanza per l'ambiente, la cui prima fase consiste
nell'identificazione del pericolo. Dopo aver identificato il pericolo, l'unità
di notifica procede in accordo con le linee-guida specificate nella tabella D:
a) alla valutazione
del rapporto tra dose o concentrazione e risposta o effetto;
b) alla valutazione
dell'esposizione per i comparti ambientali potenzialmente esposti alla sostanza
quali l'ambiente acquatico, il suolo e l'aria;
c) alla
caratterizzazione del rischio.
Art.
34
(Conclusioni
della valutazione del rischio)
1. Dopo aver svolto la
valutazione del rischio secondo il disposto degli articoli 32 e 33 e
conformemente alle disposizioni delle tabelle B, C e D, l'unità di notifica
determina, secondo quanto stabilito alla tabella E, se:
a) la sostanza non
presenta allo stato un rischio e non deve essere riesaminata finchè non siano
disponibili nuove informazioni;
b) la sostanza
presenta un rischio; in tal caso l'unità di notifica decide quali sono le
informazioni supplementari necessarie per il riesame della valutazione e rinvia
la richiesta di tali informazioni fino a quando le quantità della sostanza in
questione immesse sul mercato non raggiungano i limiti indicati negli articoli
7, comma 3, e 8, commi 3 e 4;
c) la sostanza
presenta un rischio ed è necessario chiedere immediatamente informazioni
supplementari;
d) la sostanza
presenta un rischio e l'unità di notifica formula immediatamente le necessarie
raccomandazioni per una riduzione del rischio.
2. Nei casi di cui al
comma 1, lettere b), c) e d), l'unità di notifica informa delle conclusioni il
notificante, assegnandogli un termine per presentare eventuali osservazioni e
fornire informazioni supplementari; le informazioni ricevute entro il termine
assegnato sono valute prima della trasmissione della valutazione del rischio alla
Commissione europea.
3. Si procede ad una
nuova valutazione del rischio quando l'unità di notifica riceve ulteriori
informazioni complementari dal notificante o da altra fonte.
Art.
35
(Relazione
da inviare alla Commissione europea)
1. Svolti gli
adempimenti di cui agli articoli 32, 33 e 34, l'unità di notifica invia alla
Commissione europea, una relazione contenente le informazioni previste nella
tabella F nonchè tutti gli aggiornamenti della relazione conseguenti ad
eventuali riesami della valutazione.
2. L'unità di notifica
trasmette al notificante, su sua richiesta, l'eventuale nuova valutazione del
rischio conseguente all'espletamento della procedura comunitaria connessa alla
notifica.
Capo V
APPARATO SANZIONATORIO
Art.
36
(Sanzioni)
1. Chiunque immette
nel mercato le sostanze pericolose di cui al presente decreto in violazione
delle disposizioni in tema d'imballaggio e di etichettatura di cui agli
articoli 19, 20, 21 e 22 nonchè in violazione delle disposizioni sulla classificazione
è punito con l'ammenda da lire duecentomila a lire dieci milioni.
2. Nei casi di
maggiore gravità si applica anche la pena dell'arresto fino a sei mesi.
3. Le sanzioni di cui
ai commi 1 e 2 non si applicano al commerciante al dettaglio che pone in
vendita o comunque distribuisce per il consumo sostanze pericolose in
confezioni originali, semprechè non sia a conoscenza della violazione e la
confezione originale non presenti segni di alterazione.
4. La effettuazione di
una notifica non conforme alle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10,
11, 12 e 15 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque
milioni a lire trenta milioni. Alla stessa pena sono assoggettati coloro che
violano le disposizioni sulla pubblicità, di cui all'articolo 23, o sulla
scheda informativa, di cui all'articolo 25, o sulla valutazione del rischio di
cui all'articolo 34.
Capo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.
37
(Adempimenti
successivi)
1. Con decreto del Ministro
della sanità, da emanarsi entro il 30 aprile 1997, si provvede al recepimento
delle direttive 91/632/CEE, 92/37/CEE, 92/69/CEE, 93/21/CEE, 93/72/CEE,
93/101/CE e 94/69/CE, della Commissione, rispettivamente del 28 ottobre 1991,
del 30 aprile 1992, del 31 luglio 1992, del 27 aprile 1993, del 1° settembre
1993, del 1° novembre 1993, e del 19 dicembre 1994 e alla pubblicazione
integrale degli allegati da I a IX.
2. Con decreto del
Ministro della sanità, previa comunicazione al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e al Ministro dell'ambiente, si provvede al
recepimento di ulteriori direttive tecniche di modifica degli allegati; il
decreto è emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente ogni qualvolta la nuova
direttiva preveda poteri discrezionali per il proprio recepimento.
3. I decreti di cui ai
commi 1 e 2, salvo che sia diversamente indicato dalle direttive che con essi
si recepiscono, concedono sei mesi per lo smaltimento delle sostanze pericolose
già immesse sul mercato alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, non conformi, nell'imballaggio e
nell'etichettatura, alle disposizioni dei decreti medesimi.
Art.
38
(Disposizioni
finali)
1. Le disposizioni di
cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, e quelle di
cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e 20
febbraio 1988, n. 141, non si applicano alle sostanze di cui all'articolo 1,
comma 1.
2. Le disposizioni
concernenti le schede dei dati di sicurezza di cui all'articolo 25 entrano in
vigore sei mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
3. E' consentita fino
al 31 dicembre 2000 l'immissione sul mercato di sostanze la cui etichetta reca
il: "numero CEE" e la dicitura: "etichettatura CEE".
4. Sono abrogati gli
articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981,
n. 927.
Tabella A (articolo 21)
Dimensioni e caratteristiche delle etichette
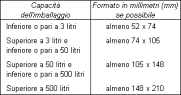
Ogni simbolo deve
occupare almeno un decimo della superficie dell'etichetta e misurare almeno 1
centimetro quadrato.
L'etichetta deve aderire
con tutta la sua superficie all'imballaggio che contiene direttamente la
sostanza.
Le etichette dei
suddetti formati sono destinate esclusivamente a contenere le informazioni
richieste dal presente decreto ed eventualmente indicazioni complementari in
materia di igiene o sicurezza.
Tabella B (articolo 32)
Valutazione del rischio: Salute umana (tossicità)
PARTE A
La valutazione del
rischio svolta in conformità dell'articolo 32 deve tener conto dei seguenti effetti
tossici potenziali e delle categorie di popolazione potenzialmente esposte.
Effetti
1) Tossicità acuta
2) Irritazione
3) Corrosività
4) Sensibilizzazione
5) Tossicità per dose
ripetuta
6) Mutagenicità
7) Cancerogenicità
8) Tossicità riproduttiva
Categorie di
popolazioni
1) Lavoratori
2) Consumatori
3) Uomo esposto
direttamente attraverso l'ambiente
PARTE B
1. Identificazione
del pericolo
1.1. Qualora sia stato
eseguito il saggio appropriato per l'identificazione del pericolo in merito ad
un dato effetto potenziale della sostanza, e qualora i risultati del saggio non
abbiano condotto alla sua classificazione non è necessario procedere alla
caratterizzazione del rischio per l'effetto in questione, a meno che non
sussistano altri validi motivi di preoccupazione, per esempio, risultati
positivi dei saggi in vitro di mutagenicità.
1.2. Qualora non sia
ancora stato eseguito il saggio appropriato per l'identificazione del pericolo
in merito ad un dato effetto potenziale la caratterizzazione del rischio in
merito a tale effetto non è necessaria a meno che non sussistano altri validi
motivi di preoccupazione, per esempio, considerazioni relative all'esposizione
o indicazioni di tossicità potenziale basata sulla relazione struttura
attività.
2. Valutazione del
rapporto tra dose o concentrazione e risposta o effetto
2.1. Per la
valutazione della tossicità a dose ripetuta e della tossicità riproduttiva
occorre valutare il rapporto dose-risposta e, se possibile, determinare il
NOAEL (no-observed-adverse-effect-level). Se non è possibile determinare il
NOAEL occorre determinare la dose/concentrazione più bassa correlata con
effetto dannoso, cioè il LOAEL (lowest-observed-adverse-effect-level).
2.2. Per le prove di
tossicità acuta, corrosività e irritazione non è generalmente possibile
determinare il NOAEL o il LOAEL basandosi sui risultati delle prove svolte in
base al presente decreto. Per la tossicità acuta occorre determinare la DL 50 o
la CL 50 oppure, qualora si ricorra alla procedura a dose fissa, la dose
discriminante. Per gli altri effetti sarà sufficiente determinare se la
sostanza in questione ha la capacità intrinseca di causare tale effetto.
2.3. Per le prove di mutagenicità
e cancerogenicità è sufficiente determinare se la sostanza in questione ha la
capacità intrinseca di causare tali effetti. Tuttavia, qualora sia dimostrato
che una determinata sostanza identificata come cancerogena non è genotossica,
sarà opportuno determinare il NOAEL o LOAEL secondo quanto disposto al punto
2.1.
2.4. Per le prove di
sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie, nella misura in cui non vi
è un consenso sulla possibilità di individuare una dose/concentrazione al di
sotto della quale gli effetti dannosi non dovrebbero manifestarsi in un
soggetto già sensibilizzato ad una data sostanza, sarà sufficiente determinare
se la sostanza in questione ha la capacità intrinseca di causare tali effetti.
3. Valutazione
dell'esposizione
3.1. Occorre eseguire
una valutazione dell'esposizione per ciascuna categoria di popolazione
potenzialmente esposta alla sostanza in questione (lavoratori, consumatori e
uomo esposto indirettamente attraverso l'ambiente). Tale valutazione deve
mirare ad una stima quantitativa o qualitativa della dose/concentrazione della
sostanza alla quale può essere esposta una determinata popolazione. Detta stima
deve tener conto delle variazioni spaziali e temporali del modello di
esposizione.
3.2. La valutazione dell'esposizione
deve basarsi sulle informazioni contenute nel fascicolo tecnico trasmesso
secondo il disposto della parte 2 degli allegati VII, parte A, VII, parte B o
VII, parte C, e su ogni altra informazione rilevante eventualmente disponibile.
Per tale valutazione si deve tenere conto dei seguenti elementi:
i) dati di esposizione
misurati in maniera adeguata;
ii) quantità di
sostanza immessa sul mercato;
iii) forma di
commercializzazione o di utilizzazione della sostanza (es.: in quanto tale
oppure in quanto componente di un preparato);
iv) categorie di
utilizzazione e grado di confinamento;
v) eventualmente dati
relativi alla lavorazione;
vi) proprietà
fisico-chimiche della sostanza incluse, ove necessario, le proprietà conferitele
dal processo di lavorazione (es.: formazione di aerosol);
vii) vie probabili di
esposizione e potenziale assorbimento;
viii) frequenza e
durata dell'esposizione;
ix) tipo e dimensione
delle popolazioni specifiche esposte, qualora tale informazione sia
disponibile.
3.3. Qualora per la
stima dei livelli di esposizione si ricorra ai metodi predittivi, si darà
preferenza ai dati rilevanti di monitoraggio derivati da sostanze
caratterizzate da un uso e un modello di esposizione analoghi.
3.4. Qualora la
sostanza in questione sia contenuta in un preparato, l'esame dell'esposizione
alla sostanza nel preparato è necessario solo se quest'ultimo è classificato
sulla base delle proprietà tossicologiche della sostanza in questione, ai sensi
della normativa sui preparati pericolosi, a meno che non vi siano altri validi
motivi di preoccupazione.
4.
Caratterizzazione del rischio
4.1. Qualora sia stato
identificato un NOAEL o LOAEL, la caratterizzazione del rischio relativa a
ciascuno degli effetti in questione deve comprendere un raffronto del NOAEL o
LOAEL con la stima della dose/concentrazione alla quale la popolazione sarà
esposta. Se è disponibile una stima quantitativa dell'esposizione, si dovrà
determinare un rapporto livello di esposizione/NOAEL o LOAEL. Basandosi sul
raffronto tra la stima quantitativa o qualitativa dell'esposizione e il NOAEL o
LOAEL l'Unità di notifica decide quale conclusione, tra le quattro previste
all'articolo 34, sia di applicazione.
4.2. Se, per uno o più
degli effetti indicati in Tabella B, parte A, il NOAEL o LOAEL non è stato
determinato, la caratterizzazione del rischio relativa ad ognuno di tali
effetti deve comprendere una valutazione, basata sulle informazioni
quantitative e/o qualitative relative all'esposizione della popolazione in
esame, della probabilità che l'effetto in questione si verifichi (1). Dopo aver
proceduto alla valutazione, l'Unità di notifica decide quale conclusione, tra
le quattro previste all'articolo 34, sia di applicazione (2).
4.3. Nel decidere
quale conclusione applicare tra le quattro previste all'articolo 34, l'Unità di
notifica tiene conto tra l'altro dei seguenti elementi:
i) l'incertezza
derivante, tra gli altri fattori, dalla variabilità dei dati sperimentali e
della variazione intra-e interspecie;
ii) la natura e la
gravità dell'effetto;
iii) la categoria di
popolazione alla quale si applica l'informazione quantitativa o qualitativa
sull'esposizione.
----------
(1) Qualora in
assenza di NOAEL o LOAEL, risulti comunque dalle prove svolte un rapporto tra
dose/concentrazione e gravità dell'effetto dannoso oppure qualora, nell'ambito
di un metodo di prova che comporta il ricorso ad un'unica dose o
concentrazione, sia possibile valutare la gravità relativa all'effetto, occorre
tener conto anche di tali informazioni nella valutazione della probabilità che
si verifichi l'effetto.
(2) Punto così
modificato dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 1998, n. 90.
5. Integrazione
5.1. In base al
disposto dell'articolo 32, comma 1, si può procedere ad una caratterizzazione
del rischio rispetto a più di un effetto dannoso potenziale o più di una
categoria di popolazione. In tal caso l'unità di notifica deve determinare
quale conclusione applicare a ciascun effetto tra le quattro previste
all'articolo 34. Dopo aver completato la valutazione del rischio, l'Unità di
notifica riesamina le diverse conclusioni ed elabora una conclusione integrata
relativa alla tossicità complessiva della sostanza in questione.
Tabella C (articolo 32)
Valutazione del rischio: Salute umana (proprietà
fisico-chimiche)
PARTE A
La valutazione del
rischio svolta in base all'articolo 32 deve tener conto degli effetti dannosi
potenziali che possono manifestarsi nelle seguenti categorie di popolazioni potenzialmente
esposte a sostanze che hanno le seguenti proprietà:
Proprietà
1) Esplosività
2) Infiammabilità
3) Potere ossidante
Categorie di
popolazioni
1) Lavoratori
2) Consumatori
3) Uomo esposto
indirettamente tramite l'ambiente
PARTE B
1. Identificazione
del pericolo
1.1. Qualora sia stato
eseguito il saggio di identificazione del pericolo per una determinata
proprietà, e qualora i risultati del saggio non abbiano condotto alla
classificazione della sostanza (articolo 34, comma 1, lettera a)), non è
necessaria la caratterizzazione del rischio per quella determinata proprietà, a
meno che non sussistano altri validi motivi di preoccupazione.
1.2. Qualora non sia
ancora stato eseguito il saggio di identificazione del pericolo per una determinata
proprietà, la caratterizzazione del rischio per quella determinata proprietà
non è necessaria, a meno che non esistano altri validi motivi di
preoccupazione.
2. Valutazione
dell'esposizione
2.1. Qualora si debba
procedere alla caratterizzazione del rischio in virtù dell'articolo 32, occorre
stabilire unicamente le condizioni di utilizzazione ragionevolmente prevedibili
in base alle informazioni sulla sostanza contenute nel fascicolo tecnico di cui
alla parte 2 degli allegati VII, parte A, VII, parte B e VII, parte C.
3.
Caratterizzazione del rischio
3.1. La
caratterizzazione del rischio comprende una valutazione della probabilità che
un effetto dannoso possa verificarsi nelle condizioni di utilizzazione ragionevolmente
prevedibili. Se da tale valutazione risulta che non si verificheranno effetti
dannosi, è generalmente d'applicazione la conclusione prevista dall'articolo
34, comma 1, lettera a). Se da tale valutazione risulta invece che si
verificherà un effetto dannoso si applica in linea generale la conclusione di
cui all'articolo 34, comma 1, lettera d).
4. Integrazione
4.1. Se vi sono
diverse raccomandazioni di riduzione del rischio riguardanti diversi effetti per
la popolazione, occorre riesaminarle dopo aver completato la valutazione del
rischio e l'Unità di notifica deve elaborare delle raccomandazioni integrate.
Tabella D (articolo 33)
Valutazione del rischio: Ambiente
1. Identificazione
del pericolo
1.1. Nel caso di
sostanze non classificate come pericolose per l'ambiente, spetta all'Unità di
notifica valutare se sussistano validi motivi per svolgere una
caratterizzazione del rischio esaminando in particolare i seguenti aspetti:
i) indicazioni di un
potenziale di bioaccumulazione;
ii) andamento della
curva tossicità/tempo nelle prove di ecotossicità;
iii) indicazioni di
altri effetti dannosi sulla base di studi di tossicità, per esempio
classificazione quale sostanza mutagena, tossica o molto tossica o nociva con
la frase di rischio R40 ("Possibilità di effetti irreversibili")
oppure R48 ("Pericolo di seri danni per la salute causati da esposizione
prolungata");
iv) dati su sostanze
strutturalmente analoghe.
1.2. Qualora l'Unità
di notifica ritenga che sussistono validi motivi per svolgere una
caratterizzazione del rischio di una sostanza non classificata pericolosa per
l'ambiente e per la quale i dati relativi agli effetti sugli organismi sono
insufficienti, essa procede, ove necessario, secondo il disposto dell'articolo
34, comma 1, lettere b) o c).
2. Valutazione del
rapporto dose o concentrazione e risposta o effetto
2.1. In questo caso si
deve prevedere la concentrazione della sostanza sotto la quale non sono
previsti effetti dannosi per il comparto ambiente a rischio. Questa
concentrazione è considerata la prevedibile concentrazione senza effetti (PNEC,
predicted no-effet concentration).
2.2. La PNEC è
determinata in base alle informazioni contenute nel fascicolo di notifica
riguardanti gli effetti sugli organismi, come descritto nel punto 5
dell'allegato VII, parte A, o VII, parte B, e in base agli studi di
ecotossicità descritti nell'allegato VIII (livelli 1 e 2).
2.3. Per il calcolo
della PNEC si applica un fattore di valutazione ai valori risultanti dai saggi
sugli organismi, per esempio LD 50 (dose letale media), CL 50 (concentrazione
letale media), CE 50 (concentrazione efficace media), CI 50 (concentrazione che
porta ad una inibizione del 50% di un dato parametro, per esempio la crescita),
NOEL(C) (NOEL concentrazione) oppure LOEL(C) (LOEL concentrazione).
2.4. Il fattore di
valutazione esprime il grado di incertezza nell'estrapolazione dei dati
sperimentali su un limitato numero di specie all'ambiente reale. Per tale
motivo, quanto più sono ampi i dati e quanto più lunga è la durata delle prove,
tanto più piccolo sarà il grado di incertezza e la dimensione del fattore di
valutazione (2).
----------
(2) Ad un valore di
CL(E) 50 derivato dai risultati delle prove di tossicità acuta è generalmente
applicato un fattore di valutazione di 1000; tuttavia tale fattore può essere
ridotto alla luce di altre informazioni pertinenti. Si applica un fattore di
valutazione più basso ad un NOEC derivato dai risultati di prova di tossicità
cronica.
3. Valutazione
dell'esposizione
3.1. La valutazione
dell'esposizione deve elaborare una previsione della concentrazione della
sostanza che si può eventualmente ritrovare nell'ambiente.
Tale concentrazione è
detta la concentrazione ambientale prevista (PEC). In alcuni casi non è
tuttavia possibile definire il PEC e occorre procedere ad una stima qualitativa
dell'esposizione.
3.2. Occorre
determinare la PEC, o in sua mancanza svolgere la stima qualitativa
dell'esposizione, solo per i comparti ambientali per i quali sono
ragionevolmente prevedibili emissioni, discariche, eliminazione o
distribuzione.
3.3. Per il calcolo
della PEC o per la stima qualitativa dell'esposizione ci si basa sulle
informazioni contenute nel fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A,
VII, parte B, VII, parte C o all'allegato VIII compresi, ove necessario, i
seguenti elementi:
i) dati di esposizione
opportunamente misurati;
ii) quantità della
sostanza commercializzata;
iii) forma di
commercializzazione o di utilizzazione della sostanza (es.: tale quale oppure
come componente di un preparato);
iv) categorie di
utilizzazione e grado di contenimento;
v) dati di
lavorazione, ove necessaria;
vi) proprietà fisico-chimiche
della sostanza, in particolare punto di fusione, punto di ebollizione,
pressione di vapore, tensione superficiale, solubilità in acqua, coefficiente
di ripartizione n-ottanolo/acqua;
vii) vie probabili di
passaggio ai comparti ambientali e potenziali di assorbimento/desorbimento e di
degradazione;
viii) frequenza e
durata dell'esposizione.
3.4. La PEC o la stima
qualitativa dell'esposizione delle sostanze commercializzate in quantità
inferiori a 10 tonnellate/anno (o cumulativamente 50 tonnellate) è normalmente
determinata per l'ambiente locale generico nel quale può verificarsi
un'emissione della sostanza.
4.
Caratterizzazione del rischio
4.1. Per un dato
comparto ambientale la caratterizzazione del rischio comprende, per quanto
possibile, un raffronto della PEC con la PNEC, in modo da poter calcolare il
rapporto PEC/PNEC. Se il rapporto PEC/PNEC è inferiore o uguale a 1, si applica
la conclusione di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a). Se il rapporto è
superiore a 1, l'Unità di notifica deve decidere, sulla base della misura di
tale rapporto e di altri fattori pertinenti, per esempio quelli elencati ai
punti 1.1(i)-1.1 (iv), quale sia la conclusione applicabile tra quelle di cui
all'articolo 34, comma 1, lettere b), c) o d).
4.2. Qualora non sia
stato possibile calcolare il rapporto PEC/PNEC, la caratterizzazione del
rischio deve comprendere una valutazione qualitativa della probabilità che si
verifichi un dato effetto nelle condizioni previste di esposizione. Dopo aver
svolto tale valutazione e tenendo conto di altri fattori pertinenti, quali
quelli elencati al punto 1.1, l'Unità di notifica decide quale delle quattro
conclusioni dell'articolo 34, comma 1, sia d'applicazione.
5. Integrazione
5.1 Secondo il
disposto dell'articolo 33, la caratterizzazione del rischio può riguardare più
di un comparto ambientale. In questo caso l'Unità di notifica deve decidere
quale delle quattro conclusioni di cui all'articolo 34 applicare a ciascun
comparto. Dopo aver completato la valutazione del rischio, l'Unità di notifica
deve riesaminare le diverse conclusioni ed elaborare una conclusione integrata
che tenga conto di tutti gli effetti di quella data sostanza per l'ambiente.
Tabella E (articolo 34)
Integrazione generale delle conclusioni
1. L'Unità di notifica
provvede a riesaminare complessivamente le conclusioni elaborate secondo il
punto 5.1 della tabella B, parte B, il punto 4.1 della tabella C, parte B, e il
punto 5.1 della tabella D, e ad integrarle successivamente tenendo conto della
totalità dei rischi identificati nella valutazione del rischio.
2. L'Unità di notifica
deve giustificare eventuali richieste di informazioni complementari, oppure
raccomandazioni di riduzione del rischio. In questo caso essa deve tener conto
dell'articolo 31, comma 4.
Tabella F (articolo 35)
Informazioni contenute nel sommario della valutazione
del rischio
1. La relazione
scritta presentata alla Commissione ai sensi dell'articolo 35 deve contenere i
seguenti elementi:
i) un sommario
generale delle conclusioni elaborate secondo l'articolo 34 e la tabella E;
ii) se alla sostanza
in questione, in relazione agli effetti dannosi potenziali per diverse
categorie di popolazione e comparti ambientali, si applica la conclusione di
cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), una dichiarazione che, in base alle
informazioni disponibili, la sostanza non desta preoccupazioni immediate e che
non è necessario un nuovo esame fino a quando il notificante non presenti nuove
informazioni in virtù degli articoli 7, 8 o 14;
iii) se, in relazione
ad uno o più effetti dannosi potenziali per diverse categorie di popolazione e
comparti ambientali si applica la conclusione di cui all'articolo 34, comma 1,
lettere b) o c), una descrizione e giustificazione delle informazioni
complementari richieste;
iv) se in relazione ad
uno o più effetti dannosi potenziali per diverse categorie di popolazione e
comparti ambientali si applica la conclusione di cui all'articolo 34, comma 1,
lettera d), una descrizione e giustificazione delle raccomandazioni di
riduzione del rischio;
v) se è stata avviata
un'azione in virtù dell'articolo 34, comma 2, un sommario delle osservazioni
del notificante in merito alle proposte dell'Unità di notifica e un sommario di
tutte le informazioni complementari pervenute.
2. Se la
caratterizzazione del rischio ha comportato l'uso dei rapporti di
esposizione-effetto descritti al punto 4 della tabella B, parte B, al punto 4
della tabella D, o l'uso dei fattori di valutazione descritti al punto 2 della
tabella D, occorre indicare tali rapporti e fattori.
Allegato A (articolo 13) (*)
Atti legislativi comunitari relativi alle categorie di
prodotti per le quali esistono
procedure comunitarie di notifica o di omologazione e
per le quali le prescrizioni
relative alle informazioni da presentare per le
categorie di sostanze identificate
sono equivalenti a quelle previste dalla Direttiva
76/548/CEE
1. Direttiva 91/414/CEE
del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio di
prodotti fitosanitari: sostanze soggette alla procedura di valutazione prevista
dall'articolo 6 di tale direttiva (G.U.C.E. L. n. 230 del 19 agosto 1991, pag.
1), recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 1995 (S.O. n.
60).
----------
(*) Così
modificato dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 1998, n. 90.
Allegato
I
(articolo 4)
Elenco delle sostanze pericolose
1. Fino alla data di
entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 37, comma 1, si
fa riferimento all'allegato I al decreto del Ministro della sanità 16 febbraio
1993, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 1993.
Allegato
II
(articolo 20)
Simboli e indicazioni di pericolo delle sostanze e
preparati pericolosi (*)
----------
Nota: Le lettere E,
O, F, F+4, T, T+, C, Xn, Xi e N non fanno parte del simbolo.
N.B.: Allegato
così sostituito dal D.M. 28 aprile 1997.
(*) Titolo così
modificato dall'art. 12, comma 2, D.Lgs. 25 febbraio 1998, n. 90.
Allegato
III
(articolo 20)
Elenco delle frasi di rischio
1. Fino alla data di
entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 37, comma 1, si
fa riferimento all'allegato III al decreto del Ministro della sanità 16
febbraio 1993, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 1993.
Allegato
IV
(articolo 20)
Elenco dei consigli di prudenza
1. Fino alla data di
entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 37, comma 1, si
fa riferimento all'allegato IV al decreto del Ministro della sanità 16 febbraio
1993, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 1993.
Allegato
V
(articolo 3)
Metodi per la determinazione delle proprietà
fisico-chimiche,
della tossicità e dell'ecotossicità
1. Fino alla data di
entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 37, comma 1, si
fa riferimento all'allegato V al decreto del Ministro della sanità 3 dicembre
1985, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1985, come integrato, da ultimo,
dall'allegato II al decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1989,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 38 del 15 febbraio 1990.
Allegato
VI
(articolo 4)
Criteri generali di classificazione e di etichettatura
delle sostanze pericolose
1. Fino alla data di
entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 37, comma 1, si
fa riferimento all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 20
febbraio 1988, n. 141.
Allegato
VII
Allegato VII parte A
Informazioni richieste per il fascicolo tecnico
(Fascicolo di base)
Qualora non sia
tecnicamente possibile o non risulti scientificamente necessario fornire una
determinata informazione, occorre addurre un'adeguata motivazione, che dovrà
essere accettata dall'autorità competente.
Va menzionato il nome dell'Ente
o degli Enti responsabili delle prove.
0. Identità del fabbricante ed identità del
notificante;
ubicazione del luogo di produzione
Per le sostanze
prodotte al di fuori della Comunità per le quali, ai fini della notifica, il notificante
è stato designato unico rappresentante del fabbricante, identità e indirizzi
degli importatori della sostanza nella Comunità.
1. Identità della sostanza
1.1. Denominazione
1.1.1. Denominazione
secondo la nomenclatura dell'IUPAC.
1.1.2. Altre
denominazioni (denominazione comune, denominazione commerciale, abbreviazione).
1.1.3. Numero CAS e
denominazione CAS (se disponibile).
1.2. Formula bruta
e formula di struttura
1.3. Composizione
della sostanza
1.3.1. Purezza in
percentuale (%).
1.3.2. Natura delle
impurità, compresi gli isomeri e i prodotti secondari.
1.3.3. Percentuale
delle principali impurità (significative).
1.3.4. Se la sostanza
contiene uno stabilizzante o un inibente oppure altri additivi precisarne: la
natura, l'ordine di grandezza:
...........................
ppm; .............................%
1.3.5. Dati relativi
allo spettro (UV, IR, NMR o spettro di massa).
1.3.6. HPLC, GC.
1.4. Metodi di
individuazione e di determinazione
Descrizione completa
dei metodi seguiti o indicazione dei relativi riferimenti bibliografici.
Dovranno essere
fornite informazioni, oltre che sui metodi di individuazione e di
determinazione, sui metodi analitici noti al notificante che consentono di
individuare una sostanza e i suoi prodotti di trasformazione dopo immissione
nell'ambiente nonchè di determinare l'esposizione umana diretta.
2. Dati relativi alla sostanza
2.0. Produzione
Le informazioni
fornite in questa parte devono essere sufficienti per consentire una stima
approssimativa ma realistica dell'esposizione umana ed ambientale connessa con
il processo produttivo. Non sono richiesti dettagli precisi del processo
produttivo, in particolare quelli di carattere delicato dal punto di vista
commerciale.
2.0.1. Procedimenti
tecnologici impiegati per la produzione.
2.0.2. Valutazione
dell'esposizione in sede di produzione:
- ambiente di lavoro;
- ambiente.
2.1. Utilizzazioni
previste
Le informazioni
fornite in questa parte devono essere sufficienti per consentire una stima
approssimativa ma realistica dell'esposizione umana ed ambientale alle
sostanze, in connessione con le utilizzazioni proposte/previste.
2.1.1. Tipi di
utilizzazione: descrivere la funzione della sostanza e gli effetti desiderati.
2.1.1.1. Procedimento
o procedimenti tecnologici in sede di impiego della sostanza (qualora noti).
2.1.1.2. Valutazione o
valutazioni dell'esposizione in sede di impiego (qualora note):
- ambiente di lavoro;
- ambiente.
2.1.1.3. Forma nella
quale la sostanza è immessa sul mercato: sostanza, preparato, prodotto.
2.1.1.4.
Concentrazione della sostanza nei preparati e nei prodotti commercializzati
(qualora nota).
2.1.2. Settori
d'applicazione e ripartizione approssimativa:
- industrie;
- operatori
dell'agricoltura e dell'artigianato;
- libera vendita.
2.1.3. Se del caso,
identità dei destinatari della sostanza, qualora sia nota.
2.1.4. Quantità e
composizione dei residui derivanti dalle utilizzazioni proposte (qualora nota).
2.2. Produzione e/o
importazione prevista per ciascuna delle utilizzazioni o ciascuno dei settori
di utilizzazione considerati
2.2.1. Produzione e/o
importazione complessiva in tonnellate/anno:
- durante il primo
anno civile;
- nei successivi anni
civili.
Per le sostanze prodotte
al di fuori della Comunità per le quali, ai fini della notifica, il notificante
è stato designato unico rappresentante del fabbricante, queste informazioni
debbono essere fornite per ciascuno degli importatori di cui al punto 0.
2.2.2. Produzione e/o
importazione ripartita secondo le indicazioni di cui ai punti 2.1.1. e 2.1.2.,
ed espressa in percentuale:
- durante il primo
anno civile;
- nei successivi anni
civili.
2.3. Metodi e
precauzioni raccomandate concernenti:
2.3.1. - la
manipolazione;
2.3.2. - il deposito;
2.3.3. - il trasporto;
2.3.4. - l'incendio
(natura dei gas di combustione o pirolisi, quando le utilizzazioni previste lo
giustificano).
2.3.5. Altri pericoli,
in particolare reazione chimica con l'acqua.
2.3.6. Se del caso, informazioni
sulle possibilità che la sostanza esploda se presentata in forma di polvere.
2.4. Misure di
emergenza in caso di dispersione accidentale
2.5. Misure di
emergenza in caso di infortunio alle persone
(esempio:
avvelenamento).
2.6. Imballaggio
3. Proprietà fisico-chimiche della sostanza
3.0. Stato della
sostanza a 20 °C e a 101,3 kPa
3.1. Punto di
fusione
3.2. Punto di
ebollizione
3.3. Densità
relativa
3.4. Tensione di
vapore
3.5. Tensione di
superficie
3.6. Idrosolubilità
3.8. Coefficiente
di ripartizione n. ottanolo/acqua
3.9. Punto
d'infiammabilità
3.10.
Infiammabilità
3.11. Proprietà
esplosive
3.12. Temperatura
di autoaccensione
3.13. Proprietà
comburenti
3.15. Granulometria
Per le sostanze che
potrebbero essere commercializzate in una forma che presenta il rischio di una
esposizione per inalazione, dovrebbe essere effettuata una prova per stabilire
la diffusione delle particelle della sostanza nella forma commercializzata.
4. Studi tossicologici
4.1. Tossicità
acuta
Per le prove di cui ai
punti da 4.1.1. a 4.1.3., le sostanze diverse dai gas devono essere
somministrate come minimo attraverso due vie, di cui una deve essere la via
orale. La scelta della seconda via dipenderà dalla natura della sostanza e
dalla probabile via dell'esposizione umana. I gas e i liquidi volatili debbono
essere somministrati per inalazione.
4.1.1. Via orale.
4.1.2. Inalazione.
4.1.3. Via cutanea.
4.1.5. Irritazione
della pelle.
4.1.6. Irritazione
degli occhi.
4.1.7.
Sensibilizzazione della pelle.
4.2.
Somministrazione ripetuta
La via di
somministrazione deve essere la più opportuna in funzione della probabile via
dell'esposizione umana, della tossicità acuta e della natura della sostanza. In
mancanza di controindicazioni si preferisce in genere la via orale.
4.2.1.
Somministrazione di tossicità ripetuta (28 giorni).
4.3. Altri effetti
4.3.1. Mutagenesi
La sostanza deve
essere esaminata con due prove. Una prova deve essere batteriologica (prova di
revisione della mutazione), con e senza attivazione metabolica. L'altra deve
essere una prova non batteriologica intesa a evidenziare aberrazioni o danni
cromosomici. In mancanza di controindicazioni questa prova deve in linea di
massima essere effettuata in vitro, con e senza attivazione metabolica. In caso
di risultati positivi in una delle due prove, sono necessarie prove
complementari, da realizzare secondo le indicazioni di cui all'allegato V.
4.3.2. Individuazione
della tossicità connessa con il ciclo riproduttivo p.m.
4.3.3. Valutazione del
comportamento tossicocinetico di una sostanza in base ai dati contenuti nel
fascicolo di base e altre informazioni pertinenti.
5. Studi ecotossicologici
5.1. Effetti sugli
organismi
5.1.1. Tossicità acuta
per i pesci.
5.1.2. Tossicità acuta
per la Daphnia.
5.1.3. Prova di
inibizione della crescita delle alghe.
5.1.6. Inibizione
batterica.
Nei casi in cui
l'effetto inibitorio di una sostanza sui batteri potesse influire sulla biodegradazione,
si dovrebbe effettuare una prova di inibizione batterica prima di procedere
alla biodegradazione.
5.2. Degradazione
- biotica;
- abiotica.
Se la sostanza non è
facilmente biodegradabile occorre valutare l'opportunità di eseguire la seguente
prova: idrolisi in funzione del pH.
5.3. Prova di
screening di assorbimento/desorbimento
6. Possibilità di rendere innocua la sostanza
6.1. A livello
industria/artigianato
6.1.1. Possibilità di
riciclaggio.
6.1.2. Possibilità di neutralizzare
gli effetti indesiderati.
6.1.3. Possibilità di
distruzione:
- discarica
controllata;
- incenerimento;
- impianto di
depurazione delle acque;
- altre.
6.2. A livello
libera vendita
6.2.1. Possibilità di
riciclaggio.
6.2.2. Possibilità di
neutralizzare gli effetti indesiderati.
6.2.3. Possibilità di
distruzione:
- discarica
controllata;
- incenerimento;
- impianto di
depurazione delle acque;
- altre.
Allegato VII parte B
Caratteristiche che formano oggetto del fascicolo
tecnico
(Fascicolo di base)
Qualora non sia
tecnicamente possibile o non risulti scientificamente necessario fornire una
determinata informazione, occorre addurre un'adeguata motivazione, che dovrà
essere accettata dall'autorità competente.
Il nome dell'Ente o
degli Enti responsabili delle prove deve essere indicato.
In aggiunta alle
informazioni di seguito richieste, l'autorità competente, qualora lo si
consideri necessario per una valutazione dei rischi, può richiedere che il
notificante fornisca le seguenti informazioni supplementari:
- tensione di vapore;
- esame di tossicità
acuta per la Daphnia.
0. Identità del fabbricante ed identità del
notificante;
ubicazione del luogo di produzione
Per le sostanze
prodotte al di fuori della Comunità per le quali, ai fini della notifica, il
notificante è stato designato unico rappresentante del fabbricante, identità e
indirizzi degli importatori della sostanza nella Comunità.
1. Identità della sostanza
1.1. Denominazione
1.1.1. Denominazione
secondo la nomenclatura dell'IUPAC.
1.1.2. Altre
denominazioni (denominazione comune, denominazione commerciale, abbreviazione).
1.1.3. Numero CAS e
denominazione CAS (se disponibile).
1.2. Formula bruta
e formula di struttura
1.3. Composizione
della sostanza
1.3.1. Purezza in
percentuale (%).
1.3.2. Natura delle
impurità, compresi gli isomeri e i prodotti secondari.
1.3.3. Percentuale
delle principali impurità (significative).
1.3.4. Se la sostanza
contiene uno stabilizzante o un inibente oppure altri additivi precisarne: la
natura, l'ordine di grandezza:
...........................
ppm; .............................%
1.3.5. Dati relativi
allo spettro (UV, IR, NMR o spettro di massa).
1.3.6. HPLC, GC.
1.4. Metodi di
individuazione e di determinazione
Descrizione completa
dei metodi seguiti o indicazione dei relativi riferimenti bibliografici.
Oltre che sui metodi
di individuazione e di determinazione, informazione sui metodi analitici noti
al notificante che consentono di individuare una sostanza e i suoi prodotti di
trasformazione dopo immissione nell'ambiente nonchè di determinare
l'esposizione umana diretta.
2. Dati relativi alla sostanza
2.0. Produzione
Le informazioni
fornite in questa parte devono essere sufficienti per consentire una stima
approssimativa ma realistica dell'esposizione umana ed ambientale connessa con
il processo produttivo. Non sono richiesti dettagli precisi del processo
produttivo, in particolare quelli di carattere delicato dal punto di vista
commerciale.
2.0.1. Procedimenti
tecnologici impiegati per la produzione.
2.0.2. Valutazione
dell'esposizione in sede di produzione:
- ambiente di lavoro;
- ambiente.
2.1. Utilizzazioni
previste
Le informazioni
fornite in questa parte devono essere sufficienti per consentire una stima
approssimativa ma realistica dell'esposizione umana ed ambientale alle
sostanze, in connessione con le utilizzazioni proposte/previste.
2.1.1. Tipi di
utilizzazione: descrivere la funzione della sostanza e gli effetti desiderati.
2.1.1.1. Procedimento
o procedimenti tecnologici in sede di impiego della sostanza (qualora noti).
2.1.1.2. Valutazione o
valutazioni dell'esposizione in sede di impiego (qualora note):
- ambiente di lavoro;
- ambiente.
2.1.1.3. Forma nella
quale la sostanza è immessa sul mercato: sostanza, preparato, prodotto.
2.1.1.4.
Concentrazione della sostanza nei preparati e nei prodotti commercializzati
(qualora nota).
2.1.2. Settori
d'applicazione e ripartizione approssimativa:
- industrie;
- operatori
dell'agricoltura e dell'artigianato;
- libera vendita.
2.1.3. Se del caso,
identità dei destinatari della sostanza, qualora sia nota.
2.2. Produzione e/o
importazione prevista per ciascuna delle utilizzazioni o ciascuno dei settori
di utilizzazione considerati
2.2.1. Produzione e/o
importazione complessiva in tonnellate/anno:
- durante il primo
anno civile;
- nei successivi anni
civili.
Per le sostanze
prodotte al di fuori della Comunità per le quali, ai fini della notifica, il
notificante è stato designato unico rappresentante del fabbricante, queste
informazioni debbono essere fornite per ciascuno degli importatori di cui al
punto 0.
2.2.2. Produzione e/o
importazione ripartita secondo le indicazioni di cui ai punti 2.1.1. e 2.1.2.,
ed espressa in percentuale:
- durante il primo
anno civile;
- nei successivi anni
civili.
2.3. Metodi e
precauzioni raccomandate concernenti:
2.3.1. - la
manipolazione;
2.3.2. - il deposito;
2.3.3. - il trasporto;
2.3.4. - l'incendio
(natura dei gas di combustione o pirolisi, quando le utilizzazioni previste lo
giustificano).
2.3.5. Altri pericoli,
in particolare reazione chimica con l'acqua.
2.4. Misure di
emergenza in caso di dispersione accidentale
2.5. Misure di
emergenza in caso di infortunio alle persone
(esempio:
avvelenamento).
2.6. Imballaggio
3. Proprietà fisico-chimiche della sostanza
3.0. Stato della
sostanza a 20 °C e a 101,3 kPa
3.1. Punto di
fusione
3.2. Punto di
ebollizione
3.6. Idrosolubilità
3.8. Coefficiente
di ripartizione n. ottanolo/acqua
3.9. Punto
d'infiammabilità
3.10.
Infiammabilità
4. Studi tossicologici
4.1. Tossicità
acuta
Per le prove da 4.1.1.
a 4.1.2. è sufficiente una via di somministrazione. Sostanze diverse dai gas
devono essere somministrate oralmente. I gas vanno somministrati per
inalazione.
4.1.1. Via orale.
4.1.2. Inalazione.
4.1.5. Irritazione
della pelle.
4.1.6. Irritazione
degli occhi.
4.1.7.
Sensibilizzazione della pelle.
4.3. Altri effetti
4.3.1. Mutagenesi
Prove batteriologiche
con e senza attivazione metabolica (prova di reversione della mutazione).
5. Studi ecotossicologici
5.2. Degradazione
- biotica.
Allegato VII parte C
Caratteristiche che formano oggetto del fascicolo
tecnico
(Fascicolo di base)
Qualora non sia
tecnicamente possibile o non risulti scientificamente necessario fornire una determinata
informazione, occorrerà addurre un'adeguata motivazione, che dovrà essere
accettata dall'autorità competente.
Il nome dell'Ente o
degli Enti responsabili delle prove deve essere indicato.
0. Identità del fabbricante ed identità del notificante
se non si tratta
della stessa persona; ubicazione del luogo di
produzione
Per le sostanze
prodotte al di fuori della Comunità per le quali, ai fini della notifica, il
notificante è stato designato unico rappresentante del fabbricante, identità e
indirizzi degli importatori della sostanza nella Comunità.
1. Identità della sostanza
1.1. Denominazione
1.1.1. Denominazione
secondo la nomenclatura dell'IUPAC.
1.1.2. Altre
denominazioni (denominazione comune, denominazione commerciale, abbreviazione).
1.1.3. Numero CAS e
denominazione CAS (se disponibile).
1.2. Formula bruta
e formula di struttura
1.3. Composizione
della sostanza
1.3.1. Purezza in
percentuale (%).
1.3.2. Natura delle
impurità, compresi gli isomeri e i prodotti secondari.
1.3.3. Percentuale
delle principali impurità (significative).
1.3.4. Se la sostanza
contiene uno stabilizzante o un inibente oppure altri additivi precisarne: la
natura, l'ordine di grandezza:
...........................
ppm; .............................%
1.3.5. Dati relativi
allo spettro (UV, IR, NMR o spettro di massa).
1.3.6. HPLC, GC.
1.4. Metodi di
individuazione e di determinazione
Descrizione completa
di metodi seguiti o indicazione dei relativi riferimenti bibliografici.
Oltre che sui metodi
di individuazione e di determinazione, informazioni sui metodi analitici noti
al notificante che consentono di individuare una sostanza e i suoi prodotti di
trasformazione dopo immissione nell'ambiente nonchè di determinare
l'esposizione umana diretta.
2. Dati relativi alla sostanza
2.0. Produzione
Le informazioni
fornite in questa parte devono essere sufficienti per consentire una stima
approssimativa ma realistica dell'esposizione umana ed ambientale connessa con
il processo produttivo. Non sono richiesti dettagli precisi del processo
produttivo, in particolare quelli di carattere delicato dal punto di vista
commerciale.
2.0.1. Procedimento o
procedimenti tecnologici impiegati per la produzione.
2.0.2. Valutazione
dell'esposizione in sede di produzione:
- ambiente di lavoro;
- ambiente.
2.1. Utilizzazioni
previste
Le informazioni
fornite in questa parte devono essere sufficienti per consentire una stima
approssimativa ma realistica dell'esposizione umana ed ambientale alle
sostanze, in connessione con le utilizzazioni proposte/previste.
2.1.1. Tipi di
utilizzazione: descrivere la funzione della sostanza e gli effetti desiderati.
2.1.1.1. Procedimento
o procedimenti tecnologici in sede di impiego della sostanza (qualora noti).
2.1.1.2. Valutazione o
valutazioni dell'esposizione in sede di impiego (qualora note):
- ambiente di lavoro;
- ambiente.
2.1.1.3. Forma nella
quale la sostanza è immessa sul mercato: sostanza, preparato, prodotto.
2.1.1.4. Concentrazione
della sostanza nei preparati e nei prodotti commercializzati (qualora nota).
2.1.2. Settori
d'applicazione e ripartizione approssimativa:
- industrie;
- operatori
dell'agricoltura e dell'artigianato;
- libera vendita.
2.1.3. Se del caso,
identità dei destinatari della sostanza, qualora sia nota.
2.2. Produzione e/o
importazione prevista per ciascuna delle utilizzazioni o ciascuno dei settori
di utilizzazione considerati
2.2.1. Produzione e/o
importazione complessiva in tonnellate/anno:
- durante il primo
anno civile;
- nei successivi anni
civili.
Per le sostanze
prodotte al di fuori della Comunità per le quali, ai fini della notifica, il
notificante è stato designato unico rappresentante del fabbricante, queste
informazioni debbono essere fornite per ciascuno degli importatori di cui al
punto 0.
2.2.2. Produzione e/o
importazione ripartita secondo le indicazioni di cui ai punti 2.1.1. e 2.1.2.,
ed espressa in percentuale:
- durante il primo
anno civile;
- nei successivi anni
civili.
2.3. Metodi e
precauzioni raccomandate concernenti:
2.3.1. - la
manipolazione;
2.3.2. - il deposito;
2.3.3. - il trasporto;
2.3.4. - l'incendio
(natura dei gas di combustione o pirolisi, quando le utilizzazioni previste lo
giustificano).
2.3.5. Altri pericoli,
in particolare reazione chimica con l'acqua.
2.4. Misure di
emergenza in caso di dispersione accidentale
2.5. Misure di
emergenza in caso di infortunio alle persone
(esempio:
avvelenamento).
2.6. Imballaggio
3. Proprietà fisico-chimiche della sostanza
3.0. Strato della
sostanza a 20 °C e a 101,3 kPa
3.9. Punto
d'infiammabilità
3.10.
Infiammabilità
4. Studi tossicologici
4.1. Tossicità
acuta
Una via di
somministrazione è sufficiente. Le sostanze diverse dai gas devono essere
somministrate per via orale. I gas vanno somministrati per inalazione.
4.1.1. Via orale.
4.1.2. Inalazione.
Allegato VII parte D
Disposizioni specifiche relative ai fascicoli tecnici
(fascicolo di base)
contenuti nelle notifiche di cui all'articolo 12
A. Ai sensi del
presente allegato s'intende per:
-
"omopolimero", un polimero costituito da una sola specie di monomeri;
-
"copolimero", un polimero costituito da più di una specie di
monomeri;
- "polimero per
cui è accettabile un insieme di prove ridotto" o "polimero IPR",
un polimero che soddisfa i criteri indicati al punto C.2;
- "famiglia di
polimeri", un gruppo di polimeri (omopolimeri o copolimeri) con diversi
pesi molecolari medi numerici o diverse composizioni derivanti da differenti
rapporti tra le unità monomeriche. La differenza di peso molecolare medio
numerico o di composizione non deve essere determinata da fluttuazioni
involontarie connesse al processo bensì da alterazioni deliberate delle
condizioni del processo senza che il processo in sè risulti modificato;
- "Mn", è il
peso molecolare medio numerico;
- "M" è il
peso molecolare.
B. Approccio per
famiglie
Al fine di evitare
prove superflue è possibile raggruppare i polimeri in famiglie.
Il concetto è quello
di sottoporre a prova i membri rappresentativi di una famiglia che presenti:
- Mn variabile per gli
omopolimeri, oppure
- una composizione
variabile con Mn approssimativamente costante per i copolimeri, oppure
- per Mn > 1.000,
Mn variabile e una composizione approssimativamente costante per i copolimeri.
Nei casi in cui si
riscontrano effetti dissimili nei membri rappresentativi in conseguenza del
campo di variazione del Mn o della composizione, sono necessarie ulteriori
prove su altri membri rappresentativi.
C. Informazioni
richieste per i fascicoli tecnici di cui all'articolo 12.
Qualora non sia
tecnicamente possibile o non risulti scientificamente necessario fornire una
determinata informazione, occorre addurre un'adeguata motivazione che dovrà
essere sottoposta alle autorità competenti.
Per la valutazione
delle proprietà del polimero si può tener conto delle informazioni disponibili
relative alle proprietà del(i) monomero(i).
Fatto salvo l'articolo
3, comma 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, le prove devono
essere effettuate conformemente alle metodologie riconosciute e raccomandate
dai competenti Organismi internazionali, qualora tali raccomandazioni esistano
(1).
Deve essere indicato il
nome dell'Ente o degli Enti responsabili delle prove.
C.1. Polimeri
sottoposti a un insieme di prove ordinario
C.1.1. Polimeri
immessi sul mercato comunitario in quantità ![]() 1 t/anno o in
quantità
1 t/anno o in
quantità ![]() 5 t
5 t
In aggiunta alle
informazioni e alle prove di cui all'articolo 7, indicate nell'allegato VII
parte A, si richiedono le seguenti informazioni specifiche sui polimeri:
1. Identità della
sostanza
1.2.1. Peso molecolare
medio numerico.
1.2.2. Distribuzione
dei pesi molecolari (DPM).
1.2.3. Identità e
concentrazione dei monomeri di partenza e delle sostanze di partenza che
saranno legati nel polimero.
1.2.4. Indicazione dei
gruppi terminali, identità e frequenza dei gruppi funzionali reattivi.
1.3.2.1. Identità dei
monomeri non reagiti.
1.3.3.1. Percentuale
dei monomeri non reagiti.
2. Dati relativi
alla sostanza
2.1.1.5. Una
dichiarazione corredata delle informazioni pertinenti che indichi se il
polimero è stato sviluppato in modo da essere degradabile nell'ambiente.
3. Proprietà
fisico-chimiche della sostanza
3.6.1. Estraibilità in
acqua.
Fatto salvo l'articolo
16, comma 1 della decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, ulteriori prove
possono essere richieste in taluni casi, ad esempio:
- fotostabilità se il polimero
non è specificamente reso stabile alla luce;
- estraibilità a lungo
termine (test di lisciviazione). A seconda dei risultati di questa prova,
possono essere richieste caso per caso prove appropriate di lisciviazione (1).
C.1.2. Polimeri immessi
sul mercato comunitario in quantità < 1 t/anno o in quantità totali < 5
t. ma ![]() 100 kg/anno,
oppure in quantità totali
100 kg/anno,
oppure in quantità totali ![]() 500 kg
500 kg
In aggiunta alle
informazioni e ai test di cui all'articolo 8, indicati nell'allegato VII parte
B, si richiedono le seguenti informazioni specifiche sui polimeri:
1. Identità della
sostanza
1.2.1. Peso molecolare
medio numerico.
1.2.2. Distribuzione
dei pesi molecolari (DPM).
1.2.3. Identità e
concentrazione dei monomeri di partenza e delle sostanze di partenza che
saranno legati nel polimero.
1.2.4. Indicazione dei
gruppi terminali, identità e frequenza dei gruppi funzionali reattivi.
1.3.2.1. Identità dei
monomeri non reagiti.
1.3.3.1. Percentuale
dei monomeri non reagiti.
2. Dati relativi
alla sostanza
2.1.1.5. Una
dichiarazione corredata delle informazioni pertinenti che indichi se il
polimero è stato sviluppato in modo da essere degradabile nell'ambiente.
3. Proprietà
fisico-chimiche della sostanza
3.6.1. Estraibilità in
acqua.
C.1.3. Polimeri
immessi sul mercato comunitario in quantità < 100 kg/anno o in quantità
totali < 500 kg.
In aggiunta alle
informazioni e alle prove di cui all'articolo 8, indicate nell'allegato VII
parte C, si richiedono le seguenti informazioni specifiche sui polimeri:
1. Identità della
sostanza
1.2.1. Peso molecolare
medio numerico.
1.2.2. Distribuzione
dei pesi molecolari (DMP).
1.2.3. Identità e
concentrazione dei monomeri di partenza e delle sostanze di partenza che
saranno legate nel polimero
1.2.4. Indicazione dei
gruppi terminali, identità e frequenza dei gruppi funzionali reattivi.
1.3.2.1. Identità dei
monomeri non reagiti.
1.3.3.1. Percentuale
di monomeri non reagiti.
2. Dati relativi
alla sostanza
2.1.1.5. Una
dichiarazione corredata delle informazioni pertinenti che indichi se il
polimero è stato sviluppato in modo da essere degradabile nell'ambiente.
C.2. Polimeri per i
quali è accettabile un insieme di prove ridotto
In determinate condizioni
l'insieme di prove del fascicolo di base per i polimeri può essere ridotto.
Le sostanze con un
elevato peso molecolare medio numerico, un basso contenuto di specie a basso
peso molecolare e con una scarsa solubilità/estraibilità sono considerate non
biologicamente disponibili. Di conseguenza per individuare i polimeri per i
quali un insieme ridotto di prove è accettabile, si deve ricorrere ai seguenti
criteri:
Per i polimeri non
facilmente degradabili immessi sul mercato comunitario in quantità ![]() 1 t/anno o in
quantità totali
1 t/anno o in
quantità totali ![]() 5 t, i criteri
in base ai quali si deve stabilire per quali polimeri è accettabile un insieme
di prove ridotto sono i seguenti:
5 t, i criteri
in base ai quali si deve stabilire per quali polimeri è accettabile un insieme
di prove ridotto sono i seguenti:
I. un elevato peso
molecolare medio numerico (Mn) (*);
II. estraibilità in
acqua (3.6.1)
< 10 mg/l escluso
ogni apporto derivante da additivi e impurità;
III. pesi molecolari
< 1.000 in percentuale inferiore all'1%; questa percentuale si riferisce
soltanto alle molecole (componenti) direttamente derivate da uno o più monomeri,
questo(i) ultimo(i) compreso(i), ed escluse altre componenti quali additivi o
impurità.
Qualora tutti i
criteri siano rispettati, per il polimero in questione è accettabile il ricorso
ad un insieme di prove ridotto.
Nel caso in cui
polimeri non facilmente degradabili siano immessi sul mercato comunitario in
quantità < 1 t/anno o in quantità totale < 5 t, è sufficiente che siano
soddisfatti i criteri I e II perchè il polimero sia inserito fra quelli per cui
un insieme di prove ridotto è accettabile.
Qualora non sia
possibile provare il rispetto dei criteri mediante le prove stabilite, il
notificante deve dimostrare il rispetto di tali criteri con altri mezzi.
In talune circostanze
si possono richiedere prove tossicologiche ed ecotossicologiche.
----------
(*) L'autorità
che riceve la notifica decide sotto la propria responsabilità se il polimero
soddisfa tale criterio.
C.2.1. Polimeri
immessi sul mercato comunitario in quantità ![]() 1 t/anno o in
quantità totale
1 t/anno o in
quantità totale ![]() 5 t
5 t
0. Identità del fabbricante ed identità del
notificante;
ubicazione del luogo di produzione
Per le sostanze
prodotte al di fuori della Comunità per le quali, ai fini della notifica, il
notificante è stato designato unico rappresentante del fabbricante: identità e
indirizzi degli importatori della sostanza nella Comunità.
1. Identità della sostanza
1.1. Denominazione
1.1.1. Denominazione
secondo la nomenclatura IUPAC.
1.1.2. Altre
denominazioni (denominazione comune, denominazione commerciale, abbreviazione).
1.1.3. Numero CAS e
denominazione CAS (se disponibile).
1.2. Formula bruta
e formula di struttura
1.2.1. Peso molecolare
medio numerico.
1.2.2. Distribuzione
dei pesi molecolari (DPM).
1.2.3. Identità e
concentrazione dei monomeri di partenza e delle sostanze di partenza che
saranno legate nel polimero.
1.2.4. Indicazione dei
gruppi terminali, identità e frequenza dei gruppi funzionali reattivi.
1.3. Composizione
della sostanza
1.3.1. Grado di
purezza (in percentuale).
1.3.2. Natura delle
impurità, compresi i prodotti secondari.
1.3.2.1. Identità dei
monomeri non reagiti.
1.3.3. Percentuale
delle principali impurità (significative).
1.3.3.1.Percentuale di
monomeri non reagiti.
1.3.4. Se la sostanza
contiene uno stabilizzante o un inibente oppure altri additivi precisarne: la
natura, l'ordine di grandezza: ... ppm, ...%
1.3.5. Dati spettrali
(UV, IR, NMR o spettro di massa).
1.3.6.1. GPC.
1.4. Metodi di
individuazione e di determinazione
Descrizione completa
di metodi seguiti o indicazione dei relativi riferimenti bibliografici.
Oltre che sui metodi
di individuazione e di determinazione, fornire informazioni sui metodi
analitici noti al notificante che consentono di individuare una sostanza e i
suoi prodotti di trasformazione dopo immissione nell'ambiente nonchè di
determinare l'esposizione umana diretta.
2. Dati relativi alla sostanza
2.0. Produzione
Le informazioni
fornite in questa parte devono essere sufficienti per consentire una stima approssimativa
ma realistica dell'esposizione umana ed ambientale connessa con il processo
produttivo. Non sono richiesti dettagli precisi del processo produttivo, in
particolare quelli di carattere delicato dal punto di vista commerciale.
2.0.1. Procedimenti
tecnologici impiegati per la produzione.
2.0.2. Valutazione
dell'esposizione in sede di produzione:
- ambiente di lavoro;
- ambiente.
2.1. Utilizzazioni
previste
Le informazioni
fornite in questa parte devono essere sufficienti per consentire una stima
approssimativa ma realistica dell'esposizione umana ed ambientale alle
sostanze, in connessione con le utilizzazioni proposte/previste.
2.1.1. Tipi di
utilizzazione: descrivere la funzione della sostanza e gli effetti desiderati.
2.1.1.1. Procedimento
o procedimenti tecnologici in sede di impiego della sostanza (qualora noti).
2.1.1.2. Valutazione o
valutazioni dell'esposizione in sede di impiego (qualora note):
- ambiente di lavoro;
- ambiente.
2.1.1.3. Forma nella
quale la sostanza è immessa sul mercato: sostanza, preparato, prodotto.
2.1.1.4.
Concentrazione della sostanza nei preparati e nei prodotti commercializzati
(qualora nota).
2.1.2. Settori
d'applicazione e ripartizione approssimativa:
- industria;
- operatori
dell'agricoltura e dell'artigianato;
- libera vendita.
2.1.3. Se del caso,
identità dei destinatari della sostanza, qualora sia nota.
2.1.4. Quantità e
composizione dei rifiuti derivanti dalle utilizzazioni proposte (qualora note).
2.2. Produzione e/o
importazione prevista per ciascuna delle utilizzazioni e ciascuno dei settori
di utilizzazione considerati
2.2.1. Produzione e/o
importazione complessiva in tonnellate/anno:
- durante il primo
anno civile;
- nei successivi anni
civili.
Per le sostanze prodotte
al di fuori della Comunità per le quali, ai fini della notifica, il notificante
è stato designato unico rappresentante del fabbricante, queste informazioni
debbono essere fornite per ciascuno degli importatori di cui al punto 0.
2.2.2. Produzione e/o
importazione ripartita secondo le indicazioni di cui ai punti 2.1.1. e 2.1.2.
ed espressa in percentuale:
- durante il primo
anno civile;
- nei successivi anni
civili.
2.3. Metodi e
precauzioni raccomandati concernenti:
2.3.1. La
manipolazione.
2.3.2. Il deposito.
2.3.3. Il trasporto.
2.3.4. L'incendio
(natura dei gas di combustione o pirolisi, quando le utilizzazioni previste lo
giustificano).
2.3.5. Altri pericoli,
in particolare reazione chimica con l'acqua.
2.3.6. Se del caso,
informazioni relative alla suscettibilità all'esplosione qualora la sostanza si
presenti sotto forma di polvere.
2.4. Misure di
emergenza in caso di dispersione accidentale
2.5. Misure di
emergenza in caso di infortunio alle persone
(esempio:
avvelenamento).
2.6. Imballaggio
3. Proprietà fisico-chimiche della sostanza
3.0. Strato della
sostanza a 20 °C e a 101,3 kPa
3.1. Intervallo di
fusione
(derivato ad esempio:
dalla prova di stabilità termica)
3.3. Densità
relativa
3.6.1. Estraibilità in
acqua.
3.10.
Infiammabilità
3.11. Proprietà
esplosive
3.12.
Autoinfiammabilità
3.15. Dimensioni
delle particelle
Per le sostanze che
possono essere commercializzate in una forma tale da creare il pericolo di
esposizione per inalazione, occorrerebbe eseguire una prova per determinare la
distribuzione delle particelle della sostanza nella forma in cui sarà
commercializzata.
3.16. Stabilità
termica
3.17. Estraibilità
in:
- acqua a pH 2 e 9 a
37° C;
- cicloesano.
4. Studi tossicologici
Caso per caso, le
autorità competenti possono richiedere, senza per ciò ritardare l'accettazione
della notifica, alcune prove tossicologiche in presenza di gruppi reattivi o di
caratteristiche strutturali/fisiche o della conoscenza delle proprietà di componenti
a basso peso molecolare del polimero o di potenziali rischi di esposizione. In
particolare possono essere richieste prove sulla tossicità per inalazione (ad
esempio: 4.1.2., 4.2.1.) qualora esista un rischio potenziale di esposizione.
5. Studi ecotossicologici
Caso per caso, le
autorità competenti possono richiedere, senza per ciò ritardare l'accettazione
della notifica, prove ecotossicologiche in presenza di gruppi reattivi, di
caratteristiche strutturali/fisiche o della conoscenza di proprietà di
componenti a basso peso molecolare del polimero o di rischi potenziali di
esposizione.
In taluni casi possono
inoltre essere richieste le seguenti prove:
- fotostabilità se il
polimero non è specificamente reso stabile alla luce;
- estraibilità a lungo
termine (test di lisciviazione), a seconda dei risultati di questa prova, può
essere richiesta, caso per caso, qualsiasi opportuna prova di lisciviazione.
6. Possibilità di rendere innocua la sostanza
6.1. A livello
industria/artigianato
6.1.1. Possibilità di
riciclaggio.
6.1.2. Possibilità di
neutralizzare gli effetti indesiderati.
6.1.3. Possibilità di
distruzione:
- discarica
controllata;
- incenerimento;
- impianto di
depurazione delle acque;
- altre.
6.2. A livello
libera vendita
6.2.1. Possibilità di
riciclaggio.
6.2.2. Possibilità di
neutralizzare gli effetti indesiderati.
6.2.3. Possibilità di
distruzione:
- discarica
controllata;
- incenerimento;
- impianto di
depurazione delle acque;
- altre.
C.2.2. Polimeri immessi
sul mercato comunitario in quantità < 1 t/anno o in quantità totale < 5
t.
0. Identità del fabbricante ed identità del
notificante;
ubicazione del luogo di produzione
Per le sostanze
prodotte al di fuori della Comunità per le quali, ai fini della notifica, il
notificante è stato designato unico rappresentante del fabbricante: identità e
indirizzi degli importatori della sostanza nella Comunità.
1. Identità della sostanza
1.1. Denominazione
1.1.1. Denominazione
secondo la nomenclatura IUPAC.
1.1.2. Altre
denominazioni (denominazione comune, denominazione commerciale, abbreviazione).
1.1.3. Numero CAS e
denominazione CAS (se disponibile).
1.2. Formula bruta
e formula di struttura
1.2.1. Peso molecolare
medio numerico.
1.2.2. Distribuzione
dei pesi molecolari (DPM).
1.2.3. Identità e
concentrazione dei monomeri di partenza e delle sostanze di partenza che
saranno legate nel polimero.
1.2.4. Indicazione dei
gruppi terminali, identità e frequenza dei gruppi funzionali reattivi.
1.3. Composizione
della sostanza
1.3.1. Purezza in
percentuale (%).
1.3.2. Natura delle
impurità, inclusi i prodotti secondari.
1.3.2.1. Identità dei
monomeri non reagiti.
1.3.3. Percentuale
delle principali impurità (significative).
1.3.3.1. Percentuale
di monomeri non reagiti.
1.3.4. Se la sostanza
contiene uno stabilizzante o un inibente oppure altri additivi precisarne: la
natura, l'ordine di grandezza:
... ppm; ...%
1.3.5. Dati relativi
allo spettro (UV, IR, NMR o spettro di massa).
1.3.6.1. GPC.
1.4. Metodi di
individuazione e di determinazione
Descrizione completa
di metodi seguiti o indicazione dei relativi riferimenti bibliografici.
Oltre che sui metodi
di individuazione e di determinazione, fornire informazioni sui metodi
analitici noti al notificante che consentono di individuare una sostanza e i
suoi prodotti di trasformazione dopo immissione nell'ambiente nonchè di
determinare l'esposizione umana diretta.
2. Dati relativi alla sostanza
2.0. Produzione
Le informazioni fornite
in questa parte devono essere sufficienti per consentire una stima
approssimativa ma realistica dell'esposizione umana ed ambientale connessa con
il processo produttivo. Non sono richiesti dettagli precisi del processo
produttivo, in particolare quelli di carattere delicato dal punto di vista
commerciale.
2.0.1. Procedimenti
tecnologici impiegati per la produzione.
2.0.2. Valutazione
dell'esposizione in sede di produzione:
- ambiente di lavoro;
- ambiente.
2.1. Utilizzazioni
previste
Le informazioni
fornite in questa parte devono essere sufficienti per consentire una stima
approssimativa ma realistica dell'esposizione umana ed ambientale alle
sostanze, in connessione con le utilizzazioni proposte/previste.
2.1.1. Tipi di
utilizzazione: descrivere la funzione della sostanza e gli effetti desiderati.
2.1.1.1. Procedimento
o procedimenti tecnologici in sede di impiego della sostanza (qualora noti).
2.1.1.2. Valutazione o
valutazioni dell'esposizione in sede di impiego (qualora note):
- ambiente di lavoro;
- ambiente.
2.1.1.3. Forma nella
quale la sostanza è immessa sul mercato: sostanza, preparato, prodotto.
2.1.1.4.
Concentrazione della sostanza nei preparati e nei prodotti commercializzati
(qualora nota).
2.1.2. Settori
d'applicazione e ripartizione approssimativa:
- industrie;
- operatori
dell'agricoltura e dell'artigianato;
- libera vendita.
2.1.3. Se del caso,
identità dei destinatari della sostanza, qualora sia nota.
2.1.4. Quantità e
composizione dei rifiuti derivanti dalle utilizzazioni proposte (qualora nota).
2.2. Produzione e/o
importazione prevista per ciascuna delle utilizzazioni o ciascuno dei settori
di utilizzazione considerati
2.2.1. Produzione e/o
importazione complessiva in tonnellate/anno:
- durante il primo
anno civile;
- nei successivi anni
civili.
Per le sostanze
prodotte al di fuori della Comunità per le quali, ai fini della notifica, il
notificante sia stato designato unico rappresentante del fabbricante, queste
informazioni debbono essere fornite per ciascuno degli importatori di cui al
punto 0.
2.2.2. Produzione e/o
importazione ripartita secondo le indicazioni di cui ai punti 2.1.1. e 2.1.2.,
ed espressa in percentuale:
- durante il primo
anno civile;
- nei successivi anni
civili.
2.3. Metodi e
precauzioni raccomandate concernenti:
2.3.1. La
manipolazione.
2.3.2. Il deposito.
2.3.3. Il trasporto.
2.3.4. L'incendio
(natura dei gas di combustione o pirolisi, quando le utilizzazioni previste lo
giustificano).
2.3.5. Altri pericoli,
in particolare reazione chimica con l'acqua.
2.3.6. Se del caso,
informazioni riguardanti la possibilità che la sostanza esploda qualora si
presenti in forma di polvere.
2.4. Misure di
emergenza in caso di dispersione accidentale
2.5. Misure di emergenza
in caso di infortunio alle persone
(esempio:
avvelenamento).
2.6. Imballaggio
3. Proprietà fisico-chimiche della sostanza
3.0. Strato della
sostanza a 20 °C e a 101,3 kPa
3.1. Intervallo di
fusione
(ad esempio: derivato dal
test di stabilità termica)
3.6.1. Estraibilità in
acqua.
3.10.
Infiammabilità
---------
N.B.: Allegato
così sostituito dal D.M. 28 aprile 1997.
(1) Capoverso così
modificato dall'art. 12, comma 3, D.Lgs. 25 febbraio 1998, n. 90, con
riferimento alla direttiva 67/548/CEE.
Allegato
VIII
Informazioni e prove complementari richieste
conformemente
all'articolo 7, comma 2
Qualora non sia
tecnicamente possibile o non risulti scientificamente necessario fornire una
determinata informazione, occorrerà addurre una adeguata motivazione, che dovrà
essere accettata dall'autorità competente.
Il nome dell'Ente o
degli Enti responsabili delle prove deve essere indicato.
Livello 1
Studi
fisico-chimici
Ulteriori studi della
proprietà fisico-chimiche dipendenti dai risultati degli studi di cui
all'allegato VII. Detti studi potrebbero includere per esempio l'elaborazione
di metodi analitici che consentano di osservare e individuare una sostanza o i
suoi prodotti di trasformazione nonchè studi sui prodotti della decomposizione
termica.
Studi tossicologici
Studio di fertilità
(una specie, una generazione, maschi e femmine, via di somministrazione più
adatta).
Se nella prima
generazione si ottengono risultati dubbi, è necessario uno studio su una
seconda generazione.
In funzione delle dosi
somministrate potrebbero emergere indicazioni di teratogenicità. In tal caso è
necessario effettuare uno studio formale di teratogenesi.
- Studio di
teratogenesi (una specie, via di somministrazione più adatta).
Questo studio è
necessario se la teratogenicità non è stata esaminata o valutata nello studio
di fertilità.
- Lo studio di
tossicità subcronica e/o cronica, compresi gli studi speciali (una specie,
maschi e femmine, via di somministrazione più adatta) è necessario se dai
risultati dello studio con somministrazione ripetuta di cui all'allegato VII o
da altre informazioni pertinenti emerge la necessità di un esame più
approfondito.
Tra gli effetti che
rivelano la necessità di tale studio potrebbero ad esempio figurare:
a) lesioni gravi o
irreversibili;
b) una dose
"senza effetti" molto bassa o inesistente;
c) un chiaro rapporto,
per quanto riguarda la struttura chimica, tra la sostanza considerata ed altre
sostanze che si sono dimostrate pericolose:
- Prove complementari
di mutagenesi e/o prova o prove di screening della cancerogenesi, da effettuare
secondo le modalità di cui all'allegato V.
Se entrambe le prove
di base danno esito negativo dovranno essere effettuate altre prove
conformemente alle proprietà specifiche e all'utilizzazione proposta della
sostanza.
Se una prova o
entrambe le prove di base danno risultati positivi, la prova complementare deve
includere altri metodi di prova in vivo con gli stessi o con altri punti
finali:
- Informazioni
fondamentali di tossicocinetica.
Studi di
ecotossicità
- Studio prolungato di
tossicità sulla Daphnia magna (21 giorni).
- Prova su una pianta
superiore.
- Prova su un
lombrico.
- Ulteriori studi di
tossicità su un pesce.
- Prova di
accumulazione in una specie; una specie, preferibilmente un pesce.
- Studio o studi
complementari di degradazione, qualora gli studi di cui all'allegato VII non
abbiano provato una degradazione sufficiente.
- Studi complementari
sull'assorbimento/desorbimento in funzione dei risultati delle prove di cui
all'allegato VII.
Livello 2
Studi tossicologici
A meno che esistano
ragioni valide e giustificate per non ricorrervi, il programma delle prove deve
riguardare i seguenti aspetti:
- studio di tossicità
cronica;
- studio di
cancerogenesi;
- studio di fertilità (per
esempio: studio di riproduzione su tre generazioni); solo se si è constatato un
effetto sulla fertilità a livello 1;
- studio di
embriotossicità sugli effetti peri e postnatali;
- studio di
teratogenesi (specie non impiegate nelle prove corrispondenti del livello 1);
- ulteriori studi
tossicocinetici che includono la biotrasformazione e la farmacocinetica;
- prove complementari
per determinare la tossicità per determinati organi o la tossicità sistemica.
Studi di
ecotossicità
- Prove complementari
di accumulazione, degradazione, mobilità e assorbimento/desorbimento.
- Studi complementari
di tossicità sui pesci.
- Studi di tossicità
sugli uccelli.
- Studi complementari
di tossicità su altri organismi.
---------
N.B.: Allegato
così sostituito dal D.M. 28 aprile 1997.
Allegato
IX
PARTE A
Disposizioni relative alle chiusure di sicurezza per
la protezione dei bambini
1. Imballaggi
richiudibili
Le chiusure di sicurezza
per bambini utilizzate per imballaggi richiudibili devono rispondere alla ISO
8317 (edizione 1° luglio 1989) che riguarda "Imballaggi di sicurezza per i
bambini - Requisiti e metodi di prova degli imballaggi richiudibili"
adottata dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO).
2. Imballaggi non
richiudibili (p.m.)
3. Osservazioni
1. La conformità con
la norma suddetta può essere attestata unicamente dai laboratori che soddisfano
le norme europee EN serie 45 000.
2. Casi particolari
Se appare evidente che
un imballaggio è sufficientemente sicuro per i bambini, in quanto essi non
possono avere accesso al suo contenuto senza l'aiuto di un utensile, il saggio
può non essere effettuato.
In tutti gli altri
casi, e quando vi sono sufficienti ragioni per dubitare dell'efficacia di una
chiusura di sicurezza per bambini adottata, l'autorità nazionale può chiedere
al responsabile dell'immissione sul mercato di fornirle un attestato rilasciato
da un laboratorio di saggio di cui al punto 1 precedente, nel quale si
certifica:
- che il tipo di
chiusura è tale da non richiedere saggi secondo la norma ISO sopraindicata;
oppure
- che la chiusura in
questione, sottoposta ai saggi previsti dalla norma ISO sopraindicata, è conforme
alle prescrizioni imposte.
PARTE B
Dispositivi che permettono di rilevare i pericoli al
tatto
Le specifiche tecniche
relative ai dispositivi che consentono di rilevare i pericoli al tatto devono
essere conformi alla norma EN 272 (edizione 20 agosto 1989), relativa
all'avvertimento tattile di un pericolo.
---------
N.B.: Allegato
così sostituito dal D.M. 28 aprile 1997.