 Sorvolare a cavallo
della fotografia le distese immense della comunicazione con lo scopo di definire, in due
cartelle, l'immagine di un secolo che si sta chiudendo è impresa da far paura anche ai
più smaliziati "guru" nella nostra epoca. L'accelerazione tipica di questa fine
secolo, infatti, è tale da rendere obsolete analisi elaborate appena pochi mesi prima e
non è raro il caso di eminenti personaggi, come de Kerckhove, costretti con un ritmo
sempre crescente a cambiare opinione sulle proprie previsioni. Le difficoltà di analisi,
comunque, non derivano solo dal ritmo con cui avvengono i cambiamenti ma anche dalla loro
vastità quantitativa. Il rumore di fondo è enorme e non facile è il compito di operare
una selezione qualitativa per astrarre ciò che può essere ritenuto significativo
nell'ambito della "finestra temporale" associabile alla nostra memoria.
Sorvolare a cavallo
della fotografia le distese immense della comunicazione con lo scopo di definire, in due
cartelle, l'immagine di un secolo che si sta chiudendo è impresa da far paura anche ai
più smaliziati "guru" nella nostra epoca. L'accelerazione tipica di questa fine
secolo, infatti, è tale da rendere obsolete analisi elaborate appena pochi mesi prima e
non è raro il caso di eminenti personaggi, come de Kerckhove, costretti con un ritmo
sempre crescente a cambiare opinione sulle proprie previsioni. Le difficoltà di analisi,
comunque, non derivano solo dal ritmo con cui avvengono i cambiamenti ma anche dalla loro
vastità quantitativa. Il rumore di fondo è enorme e non facile è il compito di operare
una selezione qualitativa per astrarre ciò che può essere ritenuto significativo
nell'ambito della "finestra temporale" associabile alla nostra memoria.
Necessariamente tale selezione non potrà che essere parziale e non potrà che essere
rappresentativa di quella "geodetica" che ognuno di noi si trova a percorrere
nella porzione spazio-temporale che ha avuto casualmente la fortuna di attraversare. Ed ecco che come per incanto, i punti della
geodetica si giustappongono sincronicamente e da un immagine latente prende corpo e si
fissa la "fotografia" personale - in parte "sfuocata", in parte
"lacunosa" - di un secolo ormai agli sgoccioli.

La fotografia non è certo
espressione di questo secolo ma è grazie a lei che, in questo secolo, ci siamo abituati a
"leggere sincronicamente" la realtà. Con la sua diffusione l'informazione ha
cessato di raggiungerci in forma sequenziale, come in un libro, per apparirci in una forma
nuova, una forma che ha decretato il predominio della vista. Non che non esistessero i
dipinti o le stampe, ma tali media stanno alla fotografia come una produzione artigianale
sta alla corrispettiva produzione industriale.
E non basta; la riproduzione delle immagini su larga scala ha permesso
l'industrializzazione della "presenza" e della "memoria". Ci ha dato
l'illusione dell'ubiquità della nostra immagine, della possibilità di sopravvivere a noi
stessi. Prima l'abbiamo scoperta mezzo di indagine capace di favorire la conoscenza e la
diffusione di immagini specchio di un'illusoria oggettività, poi, résici consapevoli del
mezzo, ci ha consentito di indagare su noi stessi e di sovrappore violentemente il nostro
"sentire" alla "realtà". C'è chi lo ha fatto scegliendo la
dimensione etica, chi quella poetica, chi, ancora, quella psicanalitica. L'immagine
fotografica, lungi da essere un linguaggio settoriale, ha accompagnato la nostra
esistenza, la nostra visione del mondo, la nostra conoscenza della realtà: si è
costituita interfaccia grafica privilegiata della comunicazione umana, strumento
privilegiato attraverso il quale diffondere "consapevolezza". La nostra memoria
è stata scolpita da immagini "storiche" che con la loro carica sincronica hanno
violentemente inciso il nostro reticolo neuronale ben più di quanto possano aver fatto
altri media: chi non ricorda l'immagine del miliziano spagnolo morente, chi non ricorda
l'impronta del primo uomo sulla luna, chi non ricorda, infine, quella del piccolo uomo che
ha fermato un carrarmato in piazza Tienanmen. Questi sono solo alcuni dei tantissimi
esempi, non necessariamente i più significativi, certo tra i più proposti e dunque
famosi. L'immagine fotografica, come accade ad ogni media, si è affiancata a quelli già
esistenti senza cancellarli e non è stata spazzata via dall'affermarsi dei nuovi media.
Con il tempo, la smania di onnipresenza dell'uomo ed il suo desiderio di controllare
"memoria" hanno portato allo sviluppo di media ancor più veloci, potenti e
"penetranti" - come il cinema e la televisione - eppure, la fotografia, primo
media della modernità, non è scomparsa, anzi gode di ottima salute.
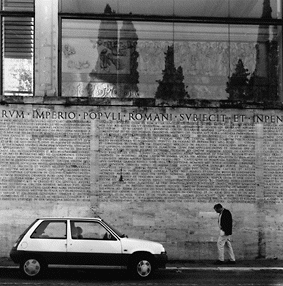 Paradossalmente
sono proprio i suoi limiti ad averne rilanciato ed amplificato la
diffusione nell'era del digitale.
Paradossalmente
sono proprio i suoi limiti ad averne rilanciato ed amplificato la
diffusione nell'era del digitale.
In questi ultimi anni la fotografia sta subendo notevoli cambiamenti e non ci riferiamo ai
canoni linguistici o estetici (cambiamenti di questo tipo avvengono in ogni epoca e sono
rintracciabili in ogni forma del comunicare), ma piuttosto alle procedure operative ed al
ruolo da essa assunto nei nuovi territori del comunicare.
Con l'avvento dei computer la fotografia si è liberata del mistero che avvolgeva
l'operare in "camera oscura" per tornare a quella "camera chiara" che
ne aveva segnato gli inizi. Nel secolo scorso i materiali erano talmente poco sensibili
che si potevano sviluppare e fissare immagini alla luce del sole, oggi, messa da parte la
chimica, si torna ad operare alla luce del giorno su immagini che restano latenti anche in
chiaro e che assumono corporeità solo al momento dell'invio in stampa. E proprio come in
alcuni "antichi" processi, oggi, si torna ad utilizzare carte di qualità
fotografica ricoperte da un sottile strato polimerico capace di assorbire gli inchiostri
di stampa: materiali diversi, ma con sorprendenti simiglianze di procedimento.
 E
la macchina fotografica, luogo per eccellenza della scrittura luminosa? Sta perdendo
evidenza, come stanno perdendo evidenza le differenze tra media. Ormai poca è la
distinzione tra una cinepresa ed una camera fotografica: video, suoni ed immagini fisse
possono essere catturate dallo stesso apparecchio, possono essere integrate con testi.
L'era digitale - per intenderci quella della "bit-generation", quella degli 0 e
degli 1 - sta sottolineando prepotentemente l'universalità e l'unitarietà del segno e
l'intrinseca multimedialità del comunicare: in genere non ci si tappa le orecchie nel
vedere un immagine, non si coprono le immagini quando si ascolta una relazione ad un
convegno. Suono, immagini fisse ed in movimento, testi, tutto viene registrato sullo
stesso supporto utilizzando un solo codice di trasmissione. Pensare ancora che una
qualsiasi di queste forme espressive possa essere "settoriale" vuol dire
appartenere alla preistoria del comunicare. Certo non è facile per un cervello
strutturato abituarsi ai nuovi modi del comunicare, alle nuove interfacce. Queste non
trasmettono più informazione nella sola forma diacronica, come in un testo o in un brano
musicale, ma neppure si limitano all'informazione sincronica di una immagine fotografica,
nè a quella sincronico-diacronica di un video: chiedono molto di più, chiedono
l'interazione e la capacità di esplorare mondi tridimensionali ed ipertesti; di costruire
"il proprio libro", un nuovo modo di "leggere" e comunicare, non più
quello dei mass-media ma quello dei personal-media. Per entrare in questi nuovi territori
abbiamo tutti bisogno di tornare bambini, di recuperare la capacità di meravigliarsi, di
spogliarsi di ogni supponenza, di recuperare la "plasticità neuronale" tipica
di ogni giovane generazione.
E
la macchina fotografica, luogo per eccellenza della scrittura luminosa? Sta perdendo
evidenza, come stanno perdendo evidenza le differenze tra media. Ormai poca è la
distinzione tra una cinepresa ed una camera fotografica: video, suoni ed immagini fisse
possono essere catturate dallo stesso apparecchio, possono essere integrate con testi.
L'era digitale - per intenderci quella della "bit-generation", quella degli 0 e
degli 1 - sta sottolineando prepotentemente l'universalità e l'unitarietà del segno e
l'intrinseca multimedialità del comunicare: in genere non ci si tappa le orecchie nel
vedere un immagine, non si coprono le immagini quando si ascolta una relazione ad un
convegno. Suono, immagini fisse ed in movimento, testi, tutto viene registrato sullo
stesso supporto utilizzando un solo codice di trasmissione. Pensare ancora che una
qualsiasi di queste forme espressive possa essere "settoriale" vuol dire
appartenere alla preistoria del comunicare. Certo non è facile per un cervello
strutturato abituarsi ai nuovi modi del comunicare, alle nuove interfacce. Queste non
trasmettono più informazione nella sola forma diacronica, come in un testo o in un brano
musicale, ma neppure si limitano all'informazione sincronica di una immagine fotografica,
nè a quella sincronico-diacronica di un video: chiedono molto di più, chiedono
l'interazione e la capacità di esplorare mondi tridimensionali ed ipertesti; di costruire
"il proprio libro", un nuovo modo di "leggere" e comunicare, non più
quello dei mass-media ma quello dei personal-media. Per entrare in questi nuovi territori
abbiamo tutti bisogno di tornare bambini, di recuperare la capacità di meravigliarsi, di
spogliarsi di ogni supponenza, di recuperare la "plasticità neuronale" tipica
di ogni giovane generazione.
 Ma
qual è, se esiste, il ruolo specifico della fotografia nell'era del digitale?
Ma
qual è, se esiste, il ruolo specifico della fotografia nell'era del digitale?
Sarebbe facile rispondere che, in un'era che vede la prorompente crescita
"rizomatica" (ma attenzione non priva di forte progettualità) di Internet, la
fotografia rappresenta il media che ottimizza il rapporto ricchezza di
informazioni/dimensione del documento, ma crediamo che questa sia solo una mezza verità.
L'altra metà va ricercata nello sviluppo subito dai mezzi di comunicazione. Da tempo ci
si è indirizzati verso il potenziamento e la progettazione di mezzi unidirezionali sempre
più pervasivi, miranti al controllo dei canali multimediali di accesso al cervello e a
quello delle sue reazioni. Si dice che il cervello abbia bisogno di 1 secondo o poco più
per chiudere un corto-circuito mentale sul dato proposto, un'operazione comunemente
definita "riflessione"; ecco allora che nei filmati pubblicitari la durata di un
inquadratura viene drasticamente ridotta a 1 secondo: non si lascia più al cervello la
libertà di filtrare e rifiutare il dato presentato, quest'ultimo non può che essere
assorbito e l'eventuale depurazione diventa un processo molto più complesso. Al contempo
i video- giochi diventano sempre più frenetici, sono ormai tali da richiedere una
concentrazione totale, l'assorbimento di tutte le proprie capacità mentali, abituano a
non-riflettere e a rispondere istintivamente ad uno stimolo, preparano ad agire sulla base
di "riflessi condizionati". In questo panorama la fotografia si offre come
un'oasi di riflessione, un'interfaccia che stimola a un esame pacato e "senza
tempo" dei particolari, alla ricerca dei vari piani di lettura, ad un confronto con
il pensiero dell'autore che, in quanto tale, intende trasmettere
"consapevolezza".
 Nel
terzo millennio, la fotografia potrà rappresentare un'ancora di salvezza per il
nostro "brain- frame", ma dovremo imparare, come facemmo sui banchi della scuola
per la scrittura sequenziale, i segreti della sua lettura, dovremo imparare a non farci
sommergere dal rumore di fondo che ci porta a guardare distrattamente le immagini, a non
lasciarci andare all'abitudine al media che ci fa presupporre una facilità di
realizzazione che non è mai stata e mai sarà, perchè ogni immagine nasce prima nel
cervello dell'autore, rappresenta la sua interfaccia per comunicare con il mondo.
Nel
terzo millennio, la fotografia potrà rappresentare un'ancora di salvezza per il
nostro "brain- frame", ma dovremo imparare, come facemmo sui banchi della scuola
per la scrittura sequenziale, i segreti della sua lettura, dovremo imparare a non farci
sommergere dal rumore di fondo che ci porta a guardare distrattamente le immagini, a non
lasciarci andare all'abitudine al media che ci fa presupporre una facilità di
realizzazione che non è mai stata e mai sarà, perchè ogni immagine nasce prima nel
cervello dell'autore, rappresenta la sua interfaccia per comunicare con il mondo.
Le immagini dell'articolo
Carlo Giovannella è ricercatore presso il Dipartimento di
Fisica e curatore MIFAV.

|
|
 Sorvolare a cavallo
della fotografia le distese immense della comunicazione con lo scopo di definire, in due
cartelle, l'immagine di un secolo che si sta chiudendo è impresa da far paura anche ai
più smaliziati "guru" nella nostra epoca. L'accelerazione tipica di questa fine
secolo, infatti, è tale da rendere obsolete analisi elaborate appena pochi mesi prima e
non è raro il caso di eminenti personaggi, come de Kerckhove, costretti con un ritmo
sempre crescente a cambiare opinione sulle proprie previsioni. Le difficoltà di analisi,
comunque, non derivano solo dal ritmo con cui avvengono i cambiamenti ma anche dalla loro
vastità quantitativa. Il rumore di fondo è enorme e non facile è il compito di operare
una selezione qualitativa per astrarre ciò che può essere ritenuto significativo
nell'ambito della "finestra temporale" associabile alla nostra memoria.
Sorvolare a cavallo
della fotografia le distese immense della comunicazione con lo scopo di definire, in due
cartelle, l'immagine di un secolo che si sta chiudendo è impresa da far paura anche ai
più smaliziati "guru" nella nostra epoca. L'accelerazione tipica di questa fine
secolo, infatti, è tale da rendere obsolete analisi elaborate appena pochi mesi prima e
non è raro il caso di eminenti personaggi, come de Kerckhove, costretti con un ritmo
sempre crescente a cambiare opinione sulle proprie previsioni. Le difficoltà di analisi,
comunque, non derivano solo dal ritmo con cui avvengono i cambiamenti ma anche dalla loro
vastità quantitativa. Il rumore di fondo è enorme e non facile è il compito di operare
una selezione qualitativa per astrarre ciò che può essere ritenuto significativo
nell'ambito della "finestra temporale" associabile alla nostra memoria. 