|
Perché
questo accadesse la scienza naturale avrebbe dovuto uscire dalla sua fase esclusivamente
descrittiva e diventare, appunto, biologia, cioè scienza esplicativa ma autonoma nell'oggetto,
nei principi e nei metodi da quella scienza che, con lo studio sperimentale e la
matematizzazione era andata sempre più imponendosi come "la" scienza fino ad appropriarsi,
restringendone il significato, del termine generale di fisica, etimologicamente "scienza della
natura". Ancora per tutto il Settecento, come ha notato Jacob, per caratterizzare le forze che
animano gli esseri organizzati si ricorreva al movimento che si produce continuamente nei
solidi e nei liquidi. L'inesistenza dell'idea stessa di vita è ben testimoniata dall'
Encyclopédie che, lapallissianamente, definisce la vita come "l'opposto della morte". Con
l'Ottocento, invece, comincia ad affermarsi il bisogno di individuare con precisione le
proprietà del vivente. Solo con l'affermarsi dell'evoluzionismo - non a caso "rivoluzione"
darwiniana - pur nella piena consapevolezza che il vivente sia anche esso soggetto alle leggi
universali della fisica, sembrerebbe cominciare a imporsi un nuovo modo di guardare al vivente
capace di affrancarsi dalla tradizionale disputa tra meccanicismo e vitalismo e dai relativi dogmatismi.
Né campo d'azione di forze inesplicabili, né terreno di selvaggia riduzione alle sue componenti
fisico-chimiche, il vivente emerge come mondo distinto e in una qualche misura contrapposto al
mondo delle cose inanimate e distinti e in una qualche misura contrapposti si configurano anche
gli ambiti disciplinari pertinenti. Da una parte la fisica, la scienza "esatta", con la
teorizzazione della regolarità, della ripetitività, dell'invarianza, con la matematizzazione
dei fenomeni, con le sue leggi universali e la simmetria tra spiegazione e previsione.
"Un fiocco di neve oggi è identico al primo fiocco di neve caduto"
(D'Arcy Thompson).
Dall'altra, la biologia protesa a spiegare un mondo molteplice e straordinariamente vario,
fatto "di entità separate e fortemente individualizzate, dotate di attività spontanea, nelle
forme più diverse, imprevedibili" (Ageno 1994). Da allora in poi- e ancor oggi - due descrizioni
si fronteggiano e, in una qualche misura, si oppongono: la legalità della fisica e la storicità
della biologia. Una "frattura logica" scrive Ageno, sembra separare le due scienze; una sorta
di "terra di nessuno" che disinvoltamente ci siamo abituati ad ignorare.
Ma
l'autonomia della biologia, il suo statuto di scientificità, la sua separatezza sono
effettivamente un dato acquisito e indiscusso? La specificità epistemologica della biologia è
davvero considerata oggi, da tutti i biologi, un tratto distintivo accertato e accettato e non
piuttosto il sintomo di una sua debolezza, della sua estraneità o comunque distanza dalle
scienze hard? L'emancipazione della biologia sembra, in realtà, un processo tutt'altro che
concluso e il cui lento avanzare incontra ostacoli che non provengono dall'esterno bensì dalla
biologia stessa e da quella "arrogante sicurezza del meccanicismo riduzionista" (Ageno 1986) che
ben si impersonifica, per esempio, nel biologo molecolare Francis Crick (1966) e nella sua
categorica certezza che "scopo ultimo" della moderna biologia sia proprio quello di spiegare
tutta la biologia con la fisica e la chimica. Non è affatto sguarnito il fronte di coloro
secondo i quali, per dirla con le parole del filosofo della scienza Alexander Rosemberg (1985),
considerare la teoria evoluzionistica come qualcosa di radicalmente diverso dalle teorie fisiche
sarebbe solo il sintomo di un "prematuro pessimismo" sui limiti della nostra capacità di
comprendere e spiegare i fenomeni evolutivi.
Niente
affatto infondata appare allora l'immagine, suggerita da Ageno, di una biologia
dalla personalità schizofrenica, una disciplina scissa al suo interno, come anche Ernst Mayr
ha teorizzato, tra una biologia funzionale e una biologia evoluzionistica, l'una manifestamente
affine e comunque confinante e protesa verso la fisica e la chimica, l'altra attratta dal
fluire del tempo nella dimensione dell'individualità, dell'unicità, della continuità
spazio-temporale, in una parola della storicità.
Sul
versante della prima, basti pensare al ruolo e alle acquisizioni, nel nostro secolo,
della genetica prima e della biologia molecolare successivamente. Data fatidica e emblematica
il 1901: la riscoperta delle leggi di Mendel. Da allora in poi gli incalzanti e grandiosi
progressi della genetica: la scoperta dei geni, la loro interpretazione come unità di
informazione, la decifrazione del DNA, l'evoluzione come variazione di frequenze geniche, il
calcolo dei tassi di mutazione e selezione nelle popolazioni, la vita come complesso
ingranaggio di circuiti di regolazione e di interazioni biochimiche sotto il controllo
del patrimonio ereditario. E poi, ancora, i seducendi progetti dell'oggi: il Programma Genoma
Umano, l'ingegneria genetica, la clonazione, le biotecnologie.
Scienza
"qualitativa", invece, la seconda, che privilegia l'unicità degli individui, la
causalità polimodale, la struttura gerarchica, l'emergenza imprevedibile del nuovo nel corso
del processo storico. La biologia evoluzionistica rivendica ancor oggi la sua autonomia dai
canoni imperanti costruiti sul modello delle scienze cosiddette esatte e si candida come
modello di una nuova scientificità capace, attraverso la narrazione storica, di offrire una
reale alternativa esplicativa al modello normativo imposto dalla fisica.
Essa
getta così un ponte verso le scienze sociali e le scienze umane da sempre terreno di
dibattito e di conflitto sulla conoscenza dell'individuale che, nelle scienze della vita trova
la sua sede elettiva per dilatare la tensione tra l'aspirazione a una conoscenza caratterizzata
dall'universalità, la ripetibilità, e la prevedibilità e l'esigenza opposta di privilegiare
la sostanziale diversità dei fenomeni vitali rispetto a quelli della materia inerte.
Il problema della conoscenza dell'individuale diviene così elemento primario di un più ampio
dibattito che, dall'interno della biologia e in nome della sua autonomia, conduce alla
richiesta di un ampliamento dei canoni stessi di scientificità investendo la ricerca di un
nuovo fondamento per l'unificazione della scienza e impegnando a ridiscutere la natura stessa
della spiegazione scientifica e delle teorie scientifiche, il significato delle leggi nella
scienza in generale e in particolare in biologia, il ruolo della previsione, il valore
esplicativo delle narrazioni storiche, in generale la tradizionale distinzione tra scienze
esatte e scienze storiche e umane. D'altra parte il dibattito sul rapporto tra descrizione,
spiegazione e narrazione è tutt'altro che inedito dal momento che la filosofia delle scienze
umane ha da sempre sofferto del tipo di crisi oggi presente nella riflessione epistemologica
sulle scienze naturali. Fin dagli anni '50 il dibattito sulla narrazione storica ha
rappresentato, infatti, una delle tematiche più stimolanti nell'ambito della filosofia
analitica della storia, e proprio in reazione ai tentativi dei filosofi della scienza di
portare la storia sotto l'ombrello filosofico delle scienze fisiche.
Restia,
almeno in parte, a sottomettersi al giogo del modello standard, la biologia non sembra
d'altra parte avere per ora fornito alternative realmente diverse da quelle dell'attribuzione
della imprevedibilità storica alla complessità dei fattori in gioco realizzando, su questo
terreno, una sorta di convergenza d'intenti e di prospettive con una fisica ormai anch'essa
inesorabilmente coinvolta con i problemi della complessità, dell'irreversibilità,
dell'imprevedibilità. E' proprio questa attenzione ai sistemi non lineari, ai fenomeni
dell'instabilità dinamica, ai problemi della sensibilità alle condizioni iniziali, della
sostanziale impevedibilità dello stato del sistema e, in sostanza della non coincidenza tra
determinismo e previsione, ad aver suggerito al fisico Marcello Cini (1986) la provocatoria
domanda "E' possibile una fisica darwiniana?". E' possibile che si stia verificando una sorta
di capovolgimento epistemologico in cui sarà la biologia a diventare modello di scientificità
nei confronti di una fisica a sua volta impegnata a ridiscutere dal suo interno i canoni
classici? (Cini 1994).
Si
è sostenuto che sia toccato alla biologia, attraverso Darwin e la teoria dell'evoluzione
disilludere, ancora una volta dopo la rivoluzione copernicana, l'uomo circa le sue pretese
antropocentriche. Inserendolo nell'economia della natura, essa ne ha fatto un suo oggetto di
studio e si è assunta l'onere di questa scelta forzando la tradizionale concezione di scienza
naturale fino a farla rifluire nella storia.
Bibliografia
Ageno M., Che cos'è la vita?, Leonardo, Roma, 1994.
|
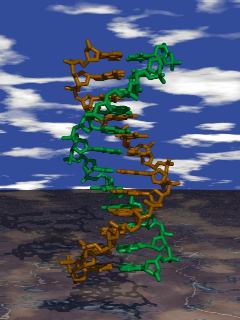 "Biologia"
è neologismo introdotto all'inizio dell'Ottocento per designare un nuovo approccio
allo "studio della vita". Dietro la trasparenza etimologica, si manifesta però immediatamente
l'effettiva complessità di ciò che si cerca di definire.
La vita, o forse meglio i viventi, come con maggior circospezione preferiscono esprimersi i
biologi attuali, mal si sottopongono al giogo delle definizioni, delle categorizzazioni, degli
schematismi. Eppure, il biologico, il regno della diversità, solo da poco ha forzato le catene
delle tassonomie nei cui schemi essenzialistici era rimasto imbrigliato per secoli.
La storia naturale, così si chiamò lo studio del vivente prima di trasformarsi in biologia, fu
in realtà semplice elenco, lista, schema logico costruito e imposto sulla natura vivente a
partire dai criteri più estrinseci e, a volte, anche fantasiosi: uso farmacologico delle piante,
presenza degli animali negli stemmi araldici, ordinamento alfabetico, commestibilità, e altro
ancora. E allorquando i classificatori si impegnarono in uno sforzo di oggettivizzazione che
riflettesse non il consuetidinario e antropocentrico uso della natura da parte dell'uomo, ma
piuttosto il suo reale ordinamento, si trovarono schierati su fronti più o meno insanabilmente
contrapposti. Il vivente è restato a lungo opaco. Tanto più inesauribilmente ricco, vario,
differenziato sul piano del visibile, quanto più resistente ad assoggettarsi a criteri univoci
e espliciti di categorizzazione. Metodisti e Sistematici, essenzialisti e nominalisti, entrambi
rivendicando a sé naturalezza e non arbitrarietà degli edifici classificatori che andavano
costruendo, non riuscirono a gestire la diversità del vivente e, soprattutto, non provarono
neanche a spiegarla.
"Biologia"
è neologismo introdotto all'inizio dell'Ottocento per designare un nuovo approccio
allo "studio della vita". Dietro la trasparenza etimologica, si manifesta però immediatamente
l'effettiva complessità di ciò che si cerca di definire.
La vita, o forse meglio i viventi, come con maggior circospezione preferiscono esprimersi i
biologi attuali, mal si sottopongono al giogo delle definizioni, delle categorizzazioni, degli
schematismi. Eppure, il biologico, il regno della diversità, solo da poco ha forzato le catene
delle tassonomie nei cui schemi essenzialistici era rimasto imbrigliato per secoli.
La storia naturale, così si chiamò lo studio del vivente prima di trasformarsi in biologia, fu
in realtà semplice elenco, lista, schema logico costruito e imposto sulla natura vivente a
partire dai criteri più estrinseci e, a volte, anche fantasiosi: uso farmacologico delle piante,
presenza degli animali negli stemmi araldici, ordinamento alfabetico, commestibilità, e altro
ancora. E allorquando i classificatori si impegnarono in uno sforzo di oggettivizzazione che
riflettesse non il consuetidinario e antropocentrico uso della natura da parte dell'uomo, ma
piuttosto il suo reale ordinamento, si trovarono schierati su fronti più o meno insanabilmente
contrapposti. Il vivente è restato a lungo opaco. Tanto più inesauribilmente ricco, vario,
differenziato sul piano del visibile, quanto più resistente ad assoggettarsi a criteri univoci
e espliciti di categorizzazione. Metodisti e Sistematici, essenzialisti e nominalisti, entrambi
rivendicando a sé naturalezza e non arbitrarietà degli edifici classificatori che andavano
costruendo, non riuscirono a gestire la diversità del vivente e, soprattutto, non provarono
neanche a spiegarla.